Home » Mafia & Mafie
Category Archives: Mafia & Mafie
Milano ’93: la strage dei buchi neri

Immagini scattate dai Vigili del Fuoco il 28 luglio 1993 (gentile cortesia del Padiglione Arte Contemporanea)
In occasione della commemorazione della strage di via Palestro 1993, una visita guidata speciale alla mostra di Luisa Lambri ho ripercorso con il curatore Diego Sileo le fasi dell’attentato e le inchieste che ne sono seguite.
Le opere fotografiche di Luisa Lambri, che si relazionano con le qualità uniche dell’architettura disegnata da Ignazio Gardella per la quale la mostra è stata appositamente progettata, saranno il punto di partenza per raccontare anche un episodio doloroso della storia del Padiglione, un trauma che segnò la storia di Milano e dell’intero paese.
Tre boati che squarciano l’Italia nella notte fra il 27 e il 28 luglio 1993, due a Roma mentre uno colpisce Milano: tre boati e una sola verità, rimasta incompleta, monca. Alcuni autori, altrettanti complici, alcune modalità e soprattutto i mandanti, troppo ancora resta oscuro a 29 anni dalla strage di via Palestro a Milano. Mese, quello della bomba al Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC), funestato, tra l’altro, dal culmine raggiunto dall’inchiesta Mani Pulite e dal suicidio, 4 giorni prima, di Raoul Gardini che doveva rendere testimonianza all’ex pm Antonio Di Pietro.
La strage di via Palestro, in particolare, uno dei sette attentati compiuti durante il biennio 1992–1993, e avvenuto il 27 luglio di 28 anni fa, è uno di quei giorni in cui i buchi neri faticano a riempirsi. Cinque morti, dodici feriti: il veicolo è esploso uccidendo uno dei Vigili urbani (Alessandro Ferrari), tre Vigili del Fuoco (Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno) e un cittadino extracomunitario (Driss Moussafir) che si trovava sul luogo.L’esplosione ha danneggiato il muro esterno del PAC e il sistema di illuminazione pubblica dell’area. Persino i vetri delle abitazioni a circa 300 metri di distanza andranno in frantumi. Poi anche la condotta del gas, posta al livello sotterraneo, prenderà fuoco. E all’alba del mattino dopo esploderà anche una sacca di gas formatasi proprio sotto il PAC, distruggendone una gran parte. La seconda esplosione lesionò infine parzialmente l’adiacente Galleria d’Arte Moderna.
Sette attentati che hanno funestato quel biennio, dicevamo: le stragi di Falcone e Borsellino; l’attentato di via Fauro a Roma, dove obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, rimasto illeso; le autobombe di Firenze in via dei Georgofili e, ancora, le chiese di Roma; infine, in mezzo, Milano, città già ferita con la madre delle stragi, quella di Piazza Fontana. E poi un ennesimo, quello tentato il 31 ottobre ’93 sempre a Roma presso lo stadio Olimpico. Un attentato non riuscito, questo, che doveva fare strage dei carabinieri. Le indagini sugli attentati, ma anche su quello mancato, confluirono poi presso la Procura della Repubblica di Firenze nel dicembre del 1994, in quanto luogo, Firenze, ove è accaduto il fatto più grave (secondo quanto stabilisce l’articolo 16 del codice penale): una famiglia intera di 4 persone, uno studente e 41 feriti.
Ma quel 27 luglio a Milano durerà molto di più che il tempo dell’esplosione stessa avvenuta alle 23.14; più dell’ora scarsa che rimaneva per passare a un giorno nuovo. I momenti paralleli che segnano il racconto dell’eccidio di via Palestro sono quelli che restano infatti più all’ombra degli altri (rispetto a esempio al momento dell’esplosione, o quando i vigili del fuoco si avvicinano all’autobomba che farà di loro carne viva, oppure, ancora, il momento dell’intervento dei loro colleghi per spegnere le fiamme e cercare di “salvare il salvabile”; persino la foto del motore dell’autobomba sbalzata via e poi immortalata dagli scatti dei pompieri). Uno dei sopravvissuti, Massimo Salsano, che ha iniziato il suo servizio presso i Vigili del fuoco proprio in quell’anno, nell’unità che poi è intervenuta, ci riferisce che le priorità in quei momenti senza tempo sono due: salvare le persone e mettere in sicuro il luogo, e cercare di non spazzare via elementi utili alle indagini. Ma quest’ultima cosa non ha certo la priorità sulla prima e il tempo per prendere decisioni è minimo. Oggi esiste il Nucleo investigativo anti-incendi (NIAT), allora nel ’93 no, ma le attenzioni, certo meno scientifiche, esistevano lo stesso. Salsano, quella sera in servizio e oggi in pensione, e il cui corpo è stato sbalzato di circa 70 metri mentre veniva raggiunto dal motore dell’autobomba (la quale non sbalzerà di 300 metri come invece spesso si ricostruisce: su questo Salsano è categorico) è stato riconosciuto insieme agli altri una “vittima del terrorismo”. È lui che insieme ai colleghi ha visto subito il fumo bianco fuoriuscire dall’auto: quello prodotto dalle micce catramate che lo emanano, come recita il documento della sentenza sulla “valutazione delle prove”, e che prendendo fuoco emette l’odore caratteristico del bitume bruciato.

Il riconoscimento dato alle vittime di terrorismo (decedute o ferite) per questa strage (legge 204/2006) già di per sé definisce quel fatto: più terrorismo che mafia. La strategia di Cosa Nostra in tal senso comincia a cambiare già alcuni anni addietro con l’omicidio di Rocco Chinnici ucciso da un’autobomba il 29 luglio 1983. Anche se le stragi del decennio successivo hanno qualcosa di diverso oltre alla mafia, qualcosa di altro, di estraneo. Su questo aspetto, le indagini del più recente biennio, vanno comunque lette insieme ai processi da poco celebrati e quelli in corso fra Caltanissetta, Palermo e Reggio Calabria.
Esistono però rispetto ai fatti elencati prima, sulla strage di Milano, tutta una serie di eventi piccoli e grandi che
li precedono, che sono a essi contemporanei e che, infine, li succedono, i quali si fanno fatica a inquadrare per bene. E a oggi non sono riusciti a inquadrarli nemmeno inquirenti e magistratura. Sono spesso però momenti fondamentali per la ricostruzione tutta di quanto accaduto. E proprio per questo restano ancora parziali o completamente oscuri.
Il buco nero per antonomasia di quel giorno a Milano, a esempio, resta, a fronte di un quadro quasi completo, il percorso che fa il tritolo all’interno dell’autobomba scelta per l’esplosione di via Palestro. Nessuno sa come è arrivato lì e chi, dei mafiosi coinvolti nel processo, sia stato. O se sia stato qualcuno di esterno, forse qualcuno che con sicurezza anche di sera non poteva essere individuato. Sicuramente nessuno di cui un collaboratore ha potuto riferire con certezza a oggi. Dei luoghi usati per la logistica invece ormai si sa tutto (un pollaio in provincia di Varese e un’abitazione di Arluno). Ma chi portò in via Palestro la Fiat Uno imbottita di esplosivo, e chi guidò l’auto di appoggio del gruppo di fuoco mafioso che operò a Milano, poche ore prima che a Roma altri uomini della stessa struttura facessero esplodere autobombe contro le basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, di tutto questo ancora nulla si conosce. Solo due anni fa per questa parte di azione è stato assolto Filippo Marcello Tutino, inizialmente accusato dal pentito che più di tutti su quelle stragi ha dato il suo contributo, Gaspare Spatuzza. Tutino è stato assolto nel 2018, in via definitiva, dall’imputazione di essere stato il presunto basista della strage. Stando alle indagini della Dda milanese era accusato di aver partecipato al furto dell’auto che poi saltò in aria e di aver fornito supporto logistico agli esecutori materiali.
Una strage che ha anche trascinato con sé due morti collaterali: quella di un affittacamere romano, Alfredo Bizzoni, il cui ruolo è stato fondamentale per facilitare il collegamento Roma-Milano; e quella di un criminale calabrese, Antonio Scarano, considerato una sorta di jolly degli stragisti vicino a boss come Matteo Messina Denaro, l’uomo di punta quest’ultimo – insieme a Giuseppe Graviano – nell’organizzazione di quelle stragi. Bizzoni fornì tre appartamenti a Roma al commando di Gaspare Spatuzza e se la cavò con una condanna a un anno e 10 mesi. Morto suicida, ma in circostanze strane, nel 2015, a Bizzoni due anni prima gli avevano confiscati beni per 15 milioni di euro e di Scarano, morto d’infarto nel 1999 mentre era sotto protezione, riferì i propri dubbi al riguardo sottolineando come lo stesso giorno entrambi dovevano effettuare il confronto in tribunale. Bizzoni sapeva qualcosa sulla trattativa Stato-mafia.
Ma a parlare di «sequenze parallele» è stato proprio il magistrato che prima di tutti indagò sulle stragi e che istruì una parte di inchiesta sui soli mandanti, la quale a oggi è seguita da altri pm come Luca Tescaroli. Filone che si apre e si chiude spesso nel silenzio generale. Buona parte di quello che poi diverrà a Palermo il famoso processo trattativa Stato-mafia, il cui dibattimento di secondo grado, mentre scriviamo, è quasi agli sgoccioli, lo dobbiamo al pm Gabriele Chelazzi morto nel bel mezzo delle indagini il 17 aprile 2003. Pronunciò queste parole Chelazzi, durante un’audizione alla Commissione antimafia del 2002 (dove non gli fu permesso però successivamente di completare il suo intervento): «Ci sono le sequenze parallele che riguardano vicende interne di cosa nostra, dinamiche di supremazia, eliminazioni, anche nel senso fisico del termine, di capi famiglia e di capi mandamento». Non solo, tra il 2002– 2003, poi, «il magistrato aveva raccolto una documentazione straordinaria e ricomposto un quadro impressionante su ciò che era accaduto con due Governi tecnici: nelle ultime settimane dell’esecutivo Amato e, soprattutto, lungo tutta la durata del Governo Ciampi», si legge anche nella relazione finale di un’altra Commissione quella presieduta da Beppe Pisanu nel 2013.
E se dobbiamo ricordare quei momenti paralleli rimasti inesplorati o poco indagati, o comunque senza una spiegazione, a esempio non possiamo non parlare della presenza di una donna bionda (il cui identikit somiglia allo stesso fatto per la strage di via Fauro a Roma), allora giovane e il cui ruolo in questi ultimi periodi le inchieste televisive che si sono occupate delle stragi hanno fatto riemergere. La prima volta che il suo identikit è comparso fu sul quotidiano l’Unità a soli due giorni dalla strage, il 29 luglio del 1993. Su questa donna la Procura di Firenze sta ancora indagando. Più volte associata, la donna, a un altro personaggio, ormai deceduto, cosiddetto Faccia da mostro, alias il poliziotto Giovanni Aiello, che secondo attività inquirenti era inserito in una struttura composta da servizi segreti, cosiddetti deviati. L’uomo, morto nel 2017 come un semplice pescatore ma le cui intercettazioni nel tempo hanno riferito ben altro, sarebbe intervenuto su molti fatti oscuri di mafia. La donna si è più volte indicata come appartenente alla struttura militare segreta Gladio, nota anche come Stay Behind operativa in modo occulto tra gli anni del secondo dopoguerra e, almeno ufficialmente, il 1990.Anche a via Fauro, a Roma, dove hanno rischiato la vita Costanzo e sua moglie, inizialmente un testimone disse di aver visto una giovane donna parlare con un uomo che era seduto al volante di quella che poi si rivelò l’autobomba, quando questa era già parcheggiata in via Fauro, alcune ore prima dell’esplosione. A Milano, invece, la donna sarebbe stata vista da altri testimoni verso le 22.30 di martedì 27 luglio accanto all’auto che poi salterà in aria: capelli lunghi, carnagione chiara, corporatura snella, lineamenti regolari, sui 27 anni. Mezz’ora dopo, 15 minuti prima dell’esplosione, una coppia di giovani passanti segnalerà ad una pattuglia di vigili urbani che, da quell’auto, parcheggiata davanti alla Villa Reale, usciva del fumo. I due si sono quindi allontanati, mentre i vigili hanno chiamato i pompieri. Di quei testimoni si è persa traccia.Di una donna, ma mora, poi si è anche eseguito un fotofit per la strage di Firenze, forse la stessa con una parrucca. Forse. Solo della bionda si è fino a oggi azzardata un’identità ma su di lei era già stata aperta un’indagine poi archiviata. L’ennesimo segreto (non mistero) di queste stragi.

Dentro le carte di questa storia di bombe e mafia è finito come indagato, per un tratto, anche l’ex terrorista nero Franco Freda, lo stesso coinvolto nella strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 avvenuta sempre a Milano.A riferirlo un detenuto che parlò ai magistrati di una confidenza fattagli in carcere dall’ideologo della (de)stabilizzazione. Freda era già stato arrestato nel 1993 con l’accusa di ricostituzione del disciolto partito fascista ed incitamento alla discriminazione razziale, all’odio e alla violenza. Per Pomarici c’era dunque anche la possibilità di una pista nera da seguire per le stragi “in continente” (indagò anche su un altro fedele di Freda, Cesare Ferri). Pista poi archiviata.
Non è la prima volta che si accostano matrici politiche alle stragi di mafia visto che proprio Giovanni Falcone era fermamente convinto della responsabilità penale nell’omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto nel 1980, dell’ex terrorista dei Nar Valerio Fioravanti di cui aveva chiesto l’arresto. Convinzione che proprio di recente, in un documento desecretato dall’attuale Commissione Antimafia, emerge chiaramente e senza ambiguità da parte dello stesso Falcone che nell’audizione, ora disponibile a tutti, indica anche la possibilità di mandanti esterni, oltre a una parte della cupola mafiosa, per l’omicidio del fratello del nostro Presidente della Repubblica. E visto anche il ruolo svolto da un membro di Cosa Nostra a Capaci, Pietro Rampulla, esperto di esplosivi ma proveniente da Ordine Nuovo, l’organizzazione terroristica degli anni ’70 che a Padova e nel Veneto in generale aveva proprio come “dirigente” Freda. Nome questo, di Pietro Rampulla, che anche spunta nel 1993.
A definire il perimetro e l’obiettivo di queste stragi tra Firenze, Milano e Roma è sempre però il pm Chelazzi che, pochi giorni prima di morire di infarto, in un colloquio poco noto all’opinione pubblica con il generale del Ros Mario Mori dell’11 aprile 2003, sentito come persona informata sui fatti, cerca di capire, leggendo dall’agenda personale che l’ufficiale aveva messo a disposizione degli inquirenti, se alcune informazioni lì indicate dagli appunti del Generale potevano riuscire a fare luce su quei «pezzi mancanti» della strage. Domande sulla sua posizione riguardo al 41 bis (anche oggetto di valutazione del processo trattativa), su alcune sue conoscenze (in particolare un giornalista che aveva avuto, lui solo, il placet da Riina per essere intervistato, e che Mori conosceva bene). Ma quello che perimetra Chelazzi durante quel colloquio è fondamentale e allo stesso tempo, in parte, nuovo anche rispetto a quanto da sempre si scrive e afferma. Per quanto riguarda Roma e Firenze – dice Chelazzi – si ha la chiara intenzione di colpire i monumenti e la Chiesa: messaggio diretto alle gerarchie ecclesiastiche, inerti secondo i riscontri emersi, di fronte alle “dure condizioni dei mafiosi”; invece per quanto riguarda Milano, e qui sta la particolarità di questa analisi, si è inteso colpire simbolicamente la stampa, non l’arte ma l’informazione. Questa motivazione viene anche spiegata dal magistrato dal fatto che secondo i collaboratori e i complici della strage l’obiettivo vero non era il PAC quella sera. C’è stato un errore di 200-300 metri. E a quella distanza in effetti vicino a via Palestro, in via Cavour si trova il Palazzo della Stampa, passaggio tra i due edifici percorribile a piedi in circa 4 minuti. D’altronde, come sempre sottolinea Chelazzi in questo interrogatorio dove Mori è poco loquace, “questa storia inizia con un giornalista”: ossia il 14 maggio del ’93 con l’attentato a Costanzo che in quei giorni era molto impegnato contro la mafia nelle sue trasmissioni.

Se il PAC è stato frutto di un obiettivo mancato, e se la distruzione di gran parte della struttura è avvenuto “per sbaglio”, se quelle morti sono avvenute per “sbaglio” (per inceppamento dell’esplosivo durante l’avvio della carica e quindi ritardo nell’esplosione), ma raggiungendo ugualmente l’obiettivo contro lo Stato, un museo di particolare visibilità già allora, il sapore che resta in bocca è ancora più amaro, il colore che esce fuori dal quadro ancora più torbido. E quei buchi neri è sempre più urgente riempirli, anche prima del prossimo anniversario: chi sono gli esterni della strage e delle stragi, chi i mandanti o i complici?
Simona Zecchi
simozecchi@gmail.com
Le parole di Graviano, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta: analisi dei fatti e i loro collegamenti
Analisi & Fatti di Simona Zecchi

Capaci (immagini wikipedia)
Operazione San Valentino. No, non si tratta di un’idea per la passata festa degli innamorati, ma del nome di una operazione di polizia contro Cosa Nostra che nell’aprile del 1981 portò all’arresto di alcuni mafiosi tra cui anche Vittorio Mangano l’ex stalliere e mafioso che lavorava per Silvio Berlusconi (numero di tessera P2 1816, gruppo 17, settore editoria come recitavano le liste ufficiali dell’associazione segreta capeggiata in Italia da Licio Gelli fuoriuscite sempre nel 1981 dalla perquisizione eseguita a Villa Wanda ad Arezzo).
E’ il 1984 quando il quotidiano palermitano L’Ora anticipa i contenuti di alcune indagini allora in corso che riguardano l’ex sindaco del sacco di Palermo, Vito Ciancimino, legate proprio alle indagini e agli arresti che portarono a quell’operazione qualche anno prima. E’ il rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S del 13 aprile 1981, infatti, a riferirvisi, utilizzato poi anche nel processo contro Marcello Dell’Utri (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e la cui pena ha espiato in cinque anni anziché 7 per concessione della libertà anticipata) tuttora indagato sia a Palermo che a Firenze sempre per mafia, nel capoluogo fiorentino è indagato insieme al suo ex datore di lavoro Berlusconi. Ed è da qui che tutto ha inizio, dal punto di vista criminal-giudiziario e anche mediatico. Quasi un bollettino “di guerra” di fatti e misfatti che portano sino ai due processi oggi in corso a Palermo (il secondo grado del processo trattativa Stato-Mafia) e a Reggio Calabria (il processo ‘Ndrangheta stragista). Sono i due processi-cuore del Paese Italia, a loro volta collegati ad altri procedimenti tuttora in corso come quello di Caltanissetta, contro Matteo Messina Denaro accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, e quelli riguardanti il presunto depistaggio di Via D’Amelio sempre a Caltanissetta, portato avanti – secondo indagini e processi in corso appunto – da ex poliziotti e magistrati (celebrato questo a Messina). E’ una matassa intricatissima i cui fili sebbene stentino a dipanarsi cominciano ad essere quanto meno individuati.
In quel servizio de L’Ora emersero rapporti fra il gruppo di una famiglia con affari a Milano (i fratelli Bono) e la Inim, società immobiliare che tentò di acquisire la società Venchi Unica dopo il fallimento del Gruppo Sindona. E’ una storia questa che da sola meriterebbe un approfondimento ma che al momento lasciamo così. E’ dalle intercettazioni di quelle indagini che si scoprono i rapporti personali fra Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano, trafficante di stupefacenti operativo a Milano, e parte della cosca mafiosa capeggiata da Rosario Spatola. Fu la prima volta che la stampa ne scrisse, poi più nulla, fino alla famosa (ma non per tutti) intervista che il giudice Paolo Borsellino il 21 maggio 1992 rilasciò ai giornalisti francesi Pierre Moscardo e Fabrizio Calvi. L’intervista fu trasmessa soltanto nel 2000 da Rainews 24 e non per intero, ma nel 1994, il settimanale L’Espresso ne aveva pubblicata la trascrizione. Nella intervista, che precede di soli due giorni la strage di Capaci, Paolo Borsellino fa intendere ai giornalisti – consegnando loro delle carte – che vi erano delle indagini aperte sui legami fra imprenditoria del Nord e Cosa Nostra e pressato dalle domande dei giornalisti, ma senza poterlo concretamente affermare, fa capire come il riferimento di quelle indagini fosse proprio il legame fra Mangano e Dell’Utri (e di conseguenza Berlusconi). In quelle vecchie indagini della Criminalpol di Milano, invece, la cui intestazione negli allegati al rapporto recita proprio così:
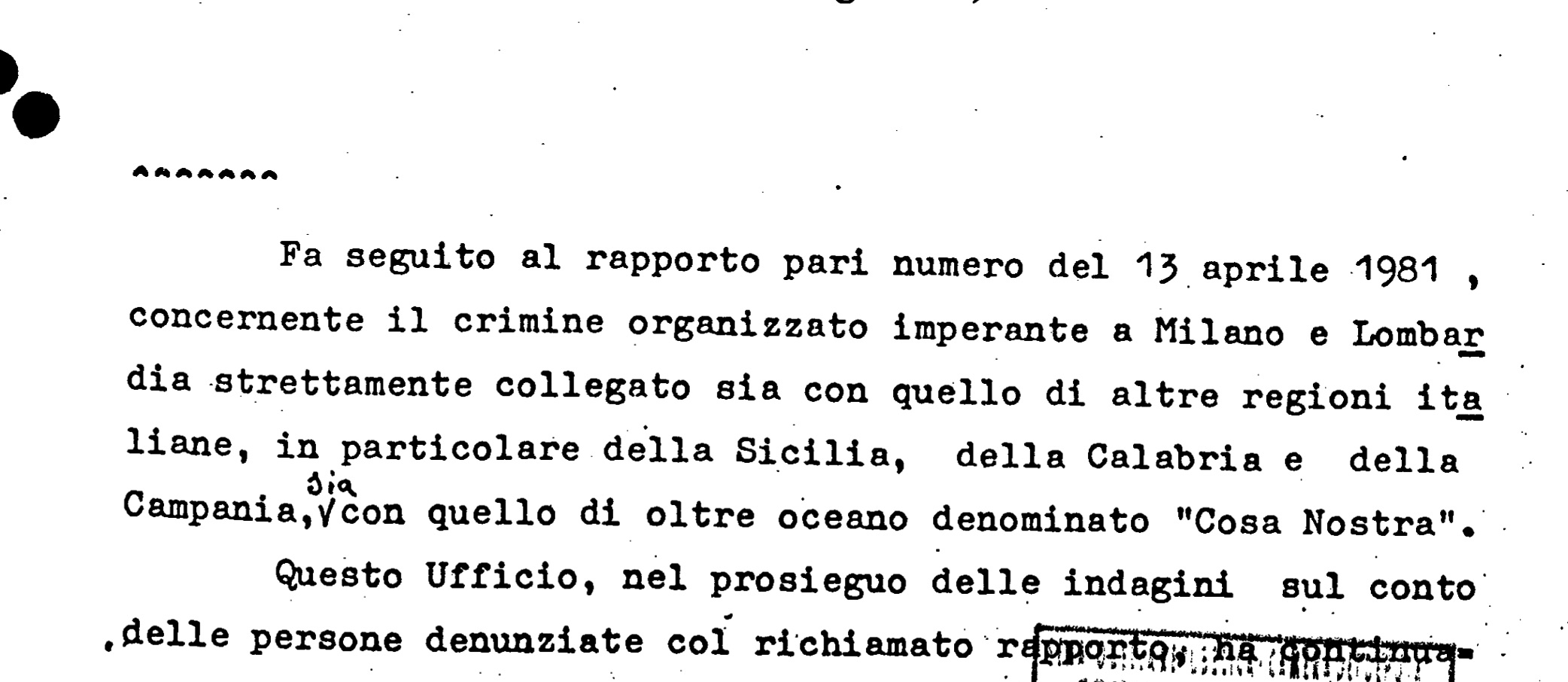
Allegato al rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S del 13 aprile 1981 (Fonte Commissione Mitrokhin)
è incestato l’origine di tutto ciò che andò a svilupparsi poi.
Secondo una notizia apparsa su Il Fatto Quotidiano a luglio del 2019 il giornalista di origini italiane, Fabrizio Calvi, è stato oggetto di rogatoria internazionale da parte della Procura di Caltanissetta per essere sentito come testimone proprio su quella intervista. Il 23 luglio 2019 Calvi rilasciò una intervista a sua volta sul Blog Mafie di Repubblica e disse:”Certamente Mangano è al centro della conversazione. In quel momento si trovava in galera ma era uno sconosciuto. Berlusconi non era ancora al centro dell’attenzione pubblica come poi lo sarà dopo, quando fece il suo partito e divenne presidente del Consiglio. Era un industriale non ancora al centro delle inchieste delle procure siciliane quanto di quelle del nord, dove era già scoppiata Tangentopoli. Ecco, Borsellino voleva evidentemente che fosse resa pubblica la storia di Mangano, accennando molto brevemente ad una inchiesta aperta anche a Palermo su Berlusconi, inchiesta di cui non si è saputo poi più nulla, per quanto io ne sappia. Penso che avrà senz’altro valutato i rischi delle sue parole per le indagini, se non per la sua stessa vita”.
Il giornalista tende a escludere che la intervista da lui fatta a Borsellino potesse essere stata la causa scatenante in sé dell’accelerazione della morte del giudice ma aggiunge, in merito alle carte consegnate loro da Borsellino:
“Si trattava dell’elenco di tutti i casi giudiziari nei quali era invischiato Berlusconi, tutti documenti giudiziari pubblici. Quando andai a cercarli mi resi conto che li avevo già quasi tutti nel mio archivio. Fu un gesto di cortesia e di fiducia che ancora mi commuove”.
Il 1981 è l’anno fondante di tante storie perché è proprio in quell’anno che il giudice Giovanni Falcone scopre a Palermo, mentre indagava su quello che si sarebbe poi rivelato come il finto sequestro Sindona, i locali della loggia Camea dove spunta anche la tessera di iscrizione dell’ex comandante militare di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli residente nella seconda metà degli anni 70 nel capoluogo siciliano (condannato a diversi ergastoli ora agli arresti domiciliari). Il 1981 è l’anno della scoperta della esistenza – già dal 1965 – della P2 dove Berlusconi entra il 26 gennaio 1978 e sembra ne esca il 31 dicembre 1982. Il 1981 è inoltre anche l’anno dell’omicidio di Stefano Bontade quando lo scettro di Cosa Nostra passa a Totò Riina mentre nel sequestro Moro del 1978 le due fazioni si erano divise sulla possibilità di supportare il governo nel far ritrovare il Presidente della DC. Sono gli anni spartiacque di tanti equilibri fra prima e seconda guerra di mafia e prima e seconda guerra di ‘ndrangheta poi, organizzazione che proprio in quegli anni si fa strada sotto le luci delle azioni roboanti di Cosa Nostra.
Le parole di Giuseppe Graviano a Reggio Calabria. Le ultime tre udienze del processo che si sta tenendo a Reggio Calabria che ha preso il nome dell’ordinanza che l’ha generato, ‘Ndrangheta stragista, hanno visto risaltare le dichiarazioni spontanee del boss Giuseppe Graviano, soprannominato dai suoi collaboratori “madre natura” e boss di riferimento del quartiere palermitano di Brancaccio (ma non solo) oltre che fedelissimo di Totò Riina. Graviano, già condannato all’ergastolo, è imputato insieme al boss della ‘ndrangheta Rocco Santo Filippone, legato alla potente cosca dei Piromalli di Gioia Tauro, di essere stato tra i mandanti degli agguati ai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, in uno dei quali furono uccisi due sottufficiali Antonino Fava e Vincenzo Garofalo mentre pattugliavano l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’impianto accusatorio della procura di Reggio Calabria nel processo vede come protagonista la ‘ndrangheta, al pari di Cosa Nostra, nell’attacco allo Stato tra il 1993 e il 1994 in quella che fu definita la stagione delle stragi continentali con gli attentati di Firenze, Milano e Roma.

Archivio Daniele Vianni (VerdeAzzurro notizie) Via Palestro Milano – Padiglione d’Arte Contemporanea
Graviano per molto tempo, e solo con qualche excursus dichiarativo sibillino in altri processi, non aveva mai chiesto di essere interrogato. Ma dal 23 gennaio 2020 ha cominciato a rispondere in video conferenza alle domande del procuratore Giuseppe Lombardo dopo aver ascoltato le intercettazioni che lo riguardano sulle conversazioni in libertà avute con un altro detenuto Umberto Adinolfi. Lo ha fatto come se fosse stato un dichiarante spontaneo cercando anche di gestire l’interrogatorio e rispondendo di fatto con lunghe dichiarazioni. Tutte e tre le udienze – la prima solo in modo generico – sono state condite da dichiarazioni su Silvio Berlusconi negando sin dall’inizio le accuse di stragi e omicidi a Graviano rivolte: sia nei procedimenti passati in giudicato, e nei quali è stato condannato, sia nel processo in questione. Sono certamente parole che sanno di messaggi, come è normale che sia da parte di chi non ha mai smesso di essere e sentirsi un boss, ma sono anche state affermazioni piene di dettagli riguardanti i rapporti di affari che Berlusconi avrebbe tenuto con il nonno di Graviano e che poi sarebbero passati in “eredità” allo stesso Graviano e al cugino. Il punto è che “madre natura” non ha fatto riferimento soltanto a fatti che sono usciti anche sui media e sulle carte di alcune sentenze che l’imputato ha dimostrato di saper analizzare e leggere (per suo torna conto certo ma non solo). Tra le affermazioni da lui pronunciate, infatti, oltre ai presunti 3 incontri che sarebbero stati consumati fra lui, Berlusconi e altre persone da lui non conosciute (udienza del 7 febbraio, riferimento a tre incontri quando Graviano era latitante), e oltre a frecciate lanciate ai vari “misteri d’Italia” dei quali certamente Graviano è a conoscenza anche per via indiretta, tra le cose da lui dette, dicevamo, a colpire sono stati quei riferimenti all’esistenza di carte/accordi privati quindi a elementi che eventualmente potrebbero provare concretamente l’esistenza di quei rapporti. Rapporti che risalgono – secondo Graviano – alla volontà del nonno materno del boss Filippo Quartararo allora facoltoso commerciante che sarebbe stato incaricato da Cosa Nostra di agganciare Berlusconi – con cui era in contatto – per investire al Nord. Cosa che sarebbe avvenuta per le pressioni di Giuseppe Greco padre del noto “Papa” Michele Greco che consigliò di investire nel settore immobiliare una cifra di circa 20 miliardi di lire. La carta privata secondo il racconto di Graviano sarebbe servita a occultare i legami di Cosa Nostra con gli investimenti immobiliari del gruppo di Berlusconi, almeno in un primo momento. Graviano insiste:
“Io sono stato arrestato per un progetto che è stato voluto da più persone. È dimostrato dal fatto che ogni giorno ricevevo visite, e non so se venivano registrato. C’erano carabinieri, poliziotti. E alla fine mi hanno detto: ‘Ora l’accuseremo per tutte le stragi d’Italia, da qui non uscirà più. E così è stato. E subito dopo ho ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare di Roma”. (Udienza del 14 febbraio 2020). Graviano cerca insomma di addebitare a un grande complotto contro di lui gli arresti che lo hanno visto protagonista. Un riferimento sibillino ma rilevante lo ha fatto durante la prima udienza del 23 gennaio nella quale al pm Lombardo Graviano aveva “consigliato” di andare a vedere il giorno del suo arresto, il 27 gennaio 1994 per capire cosa c’è dietro le stragi. Una prima lettura di superficie dopo che nelle udienze successive Graviano lo chiarisce è certamente questo “complotto” per incastrarlo. Ma un secondo livello di lettura porta invece all’ufficiale scesa in campo dell’imprenditore poi presidente del Consiglio, il 26 gennaio: il giorno prima. L’avvocato di Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha bollato come diffamatorie e prive di fondamento le parole di Graviano e, anzi, le lega a una reazione della mafia contro l’ex premier. Azioni che tuttavia Graviano stesso definisce come vero e proprio “tradimento” nei confronti della compagine mafiosa.

Via D’Amelio (Wikipedia)
Tornando a ‘San Valentino’. E’ proprio dalle ceneri di quelle prime indagini e dal rapporto riferito a inizio articolo (Rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S) che è necessario tornare per analizzare queste dichiarazioni. Nel processo che poi portò alla definitiva condanna di Marcello Dell’Utri, preceduta e seguita da diverse vicissitudini compresa la fuga dell’ex senatore di Forza Italia, poi rientrato in Italia, il pg aveva affermato che “per diciotto anni, dal 1974 al 1992, Marcello Dell’Utri è stato garante dell’accordo tra Berlusconi e Cosa nostra; in quel lasso di tempo”, aveva osservato il pg, “siamo in presenza di un reato permanente”. “Infatti, la Cassazione, con la sentenza del 2012 con cui aveva disposto un processo d’appello-bis per Dell’Utri, aveva precisato che l’accordo tra Berlusconi e Cosa nostra, con la mediazione di Dell’Utri c’è stato, si è formato nel 1974 ed è stato attuato volontariamente e consapevolmente”. La Cassazione nel 2014 confermando a 7 anni la condanna non mise in discussione queste assunzioni. E i rapporti fra Berlusconi, i mafiosi Gaetano Cinà (deceduto nel 2006), Stefano Bontade e Mimmo Teresi e Marcello Dell’Utri sono stati ricostruiti nella sentenza di primo grado del 2004 e recepiti nelle successive fino alla Cassazione nel 2014. Sentenza che si riferisce a un incontro avvenuto tra questi signori nel maggio del 1974. Nelle carte della sentenza contro Dell’Utri si parla del progetto di sequestro a Berlusconi voluto da Michele Greco il Papa – sequestro poi tramontato proprio perché si decise di trattare con l’imprenditore e affiancargli Mangano – secondo quanto riferì un collaboratore di giustizia, Antonino Giuffrè. Greco-figlio il cui padre secondo Graviano avrebbe consigliato l’investimento nelle costruzioni di Milano 2 o 3. Degli stessi investimenti senza un riferimento preciso quanto quello di Graviano ha parlato un altro collaboratore di Giustizia Francesco Di Carlo. Ed è sempre in queste carte che si parla della telefonata fra Dell’Utri e Mangano acquisita dalle carte sulle indagini della Criminalpol dell’81 che indagava fra imprenditoria del nord, cosa nostra e ‘ndrangheta. A carico di dell’Utri infatti erano stati emessi, riferisce la sentenza, “una comunicazione giudiziaria ed un decreto di perquisizione” secondo l’articolo 416bis. La sua posizione fu poi separata nel 1987 e con sentenza del 24 maggio 1990 di Milano si ritenne “insussistente la prova dell’inserimento dell’imputato Dell’Utri nel sodalizio mafioso operante a Milano”. Sono gli anni quelli indicati nella sentenza Dell’Utri ai quali fa riferimento il racconto di Graviano? La domanda è lecita.

ATTENTATO SAN GIOVANNI IN LATERANO (ROMA)
‘Ndrangheta e Cosa Nostra. Del tentativo di sequestro di Berlusconi, del quale la sentenza contro l’ex senatore di Forza Italia si parla e viene recepita nell’insieme come elemento significativo dei rapporti fra Berlusconi e Cosa Nostra mediati da Dell’Utri, esiste anche la dichiarazione di Angelo Siino, ex ‘ministro dei lavori pubblici’ di Totò Riina e collaboratore di giustizia considerato credibile da sempre, che durante una udienza del processo contro Andreotti nel 1997 fa riferimento alla ‘ndrangheta, ossia alle famiglie vertice della organizzazione calabrese, svelando così un diverso più recondito risvolto sui tentativi di rapimento dell’imprenditore e/o dei suoi figli. A rivelare per primi questa importante dichiarazione è il Corriere della Calabria nel 2013 (lo stesso anno della sentenza a Dell’Utri poi confermata dalla Cassazione) ma sono contenuti presenti nelle carte al processo Andreotti per mafia appunto, emersi soltanto alcuni anni dopo. Qui entra in scena un importante elemento cerniera tale Enzo Cafari (di cui ho scritto ne La Criminalità servente nel caso Moro , a proposito dell’omicidio del giornalista Pecorelli).

Giulio Andreotti Min. esteri e Silvio Berlusconi 1984 (Wikipedia)
Siino, riferisce la stessa sentenza di Palermo contro Andreotti e più in là negli anni recepita anche dalla sentenza contro dell’Utri, parla di un viaggio fatto a Milano con il massone calabrese Cafari – legato a tante storie delicate di ‘ndrangheta – e Bontade per cercare di convincere i calabresi – i Condello – a non rapire Berlusconi. Nelle confessioni di Siino c’è tutto il mondo descritto sopra: Sindona, la loggia Camea (“espressione nazionale rappresentata a Palermo dalla loggia Orion”) gli incontri con personaggi di spicco della ‘ndrangheta. Insomma la rete tessuta intorno a Dell’Utri e Berlusconi.
In quelle rivelazioni di Siino, infatti, si comprende come i rapporti fra Cosa nostra e ‘Ndrangheta fossero già cementati negli anni 70 e negli anni delle “stragi continentali” divengono dirimenti per una comune strategia. Il direttore allora del Corriere della Calabria, Pollicheni, che aveva condotto l’inchiesta e rivelato le parole di Siino, aveva affermato in una intervista su Il Sussidiario:
“Per la ‘Ndrangheta Berlusconi era solo un ricco imprenditore. Per Cosa nostra, che all’epoca era la leadership criminale, il Cavaliere era molto di più. Non dimentichiamo che era l’uomo della P2, tanto è vero che per salvarlo si mobilitò anche la Massoneria. Berlusconi stava iniziando a gestire le reti e i ripetitori per costruire il suo impero televisivo e si accingeva ad acquistare la Standa, da cui avrebbe tratto benefici anche Cosa nostra. Era inoltre un imprenditore vicino al Partito Socialista, cioè agli ambienti craxiani e quindi ai cementi della famiglia Gardini. Per Cosa nostra poteva rendere quindi molto di più farsi amico Berlusconi piuttosto che rapirlo.”
Le vicende della gestione delle reti e dei ripetitori per costruire l’impero televisivo sono tutte state recepite nella sentenza Dell”Utri.
E’ solo un’analisi questa dei fatti che si sono alternati in questi anni sotto una luce nuova e i loro collegamenti con le recenti vive vicende dei processi che sono in corso.
L’articolo ripreso da Antimafia 2000
NOTE: LE IMMAGINI UTILIZZATE PROVENGONO, A ECCEZIONE CHE LA’ DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, DA WIKIPEDIA. IN PARTICOLARE, PER LA FOTO DELL’ATTENTATO A SAN GIOVANNI IN LATERANO A ROMA WIKIPEDIA INDICA UN AUTORE ANONIMO: “INDECISO 42”. NEL CASO DI RIVENDICAZIONE AUTORIALE E RICHIESTA DI RIMOZIONE PREGO CONTATTARE L’INDIRIZZO simozecchi@gmail.com
QUESTO ARTICOLO PUBBLICATO SU BLOG PERSONALE DELL’AUTRICE E GIORNALISTA SIMONA ZECCHI RISPETTA TUTTI I CRISMI DEONTOLOGICI COSI’ COME INDICATI NEL TESTO UNICO DEL GIORNALISTA ED E’ INEDITO (ALLRIGHTS RESERVED)
L’omicidio Mattei e l’«Appunto 21»: due piste monche (estratto da “Massacro di un Poeta”)
E’ solo un estratto di un capitolo denso di fatti e analisi. In questo primo paragrafo ripercorro la genesi di “Petrolio” nelle intenzioni di Pier Paolo Pasolini, nei successivi spiego perché poi la chiave dell’Appunto 21 legata alla morte di Enrico Mattei è una chiave monca, che non apre la porta dove si cela il movente vero.
Le pagine mancanti
Negli ultimi cinque anni di indagine, ovvero dal 2010 al maggio 2015, si è fatto spesso riferimento a Petrolio, l’ultima opera, incompiuta, di Pier Paolo Pasolini, la cui stesura ebbe inizio nella primavera del 1972. Una «presenza» che ha viaggiato in parallelo, senza mai incontrarsi concretamente, con l’inchiesta sulla morte del poeta. Un corpus «ingombrante» verso cui personaggi della politica, dell’industria, testimoni e intellettuali hanno via via mostrato il loro interesse appropriandosi di questo o quell’elemento. Il vocio che si è raccolto intorno ad essa ha smorzato però alcune verità. La Procura di Roma, infatti, non si è mai addentrata nelle pagine di quel testo alla ricerca di elementi che permettessero agli investigatori di andare oltre il movente sessuale ampiamente smontato nel presente libro. Un magistrato di un’altra procura lo ha fatto, vedremo come.
Petrolio o Vas (titolo poi scartato dall’autore) è un vero e proprio documento, come lo è La Divina Mimesis e, sotto altra forma, il film Salò. Tutte e tre le opere sono percorse dallo schema dei gironi infernali danteschi, trasposti in un contesto contemporaneo, sul quale il poeta affonda le sue critiche taglienti e percorre la sua personale indagine. Lo stile usato in Petrolio è quello «che si adopera per la saggistica, per certi articoli giornalistici, per le recensioni, per le lettere private o anche per la poesia: rari sono i passi che si possono chiamare [decisamente] narrativi», come scrive Pasolini stesso nella lettera ad Alberto Moravia mai spedita e apposta in calce all’opera. Una sorta di superamento della forma romanzo, la quale, secondo il poeta, non è più sufficiente a far comprendere la verità dei fatti al lettore:
“Se io dessi corpo a ciò che qui è solo potenziale, e cioè inventassi la scrittura necessaria a fare di questa storia un oggetto, una macchina narrativa che funziona da sola nell’immaginazione del lettore, dovrei per forza accettare quella convenzionalità che è in fondo giuoco. Non ho voglia più di giocare”.
All’amico e scrittore Paolo Volponi, Pasolini riferisce:
“Deve essere un lungo romanzo, di almeno duemila pagine. S’intitolerà Petrolio. Ci sono tutti i problemi di questi venti anni della nostra vita italiana politica, amministrativa, della crisi della nostra repubblica: con il petrolio sullo sfondo come grande protagonista della divisione internazionale del lavoro, del mondo del capitale che è quello che determina poi questa crisi, le nostre sofferenze, le nostre immaturità, le nostre debolezze, e insieme le condizioni di sudditanza della nostra borghesia, del nostro presuntuoso neocapitalismo”.
Lo scrittore corsaro, dunque, non ha più voglia di «giocare». È un cambio di passo il suo: linguistico, stilistico e di forma. Vuole confrontarsi con la realtà utilizzando il giornalismo investigativo (mediante l’uso incrociato delle fonti e il loro collegamento) pur non rinunciando alla sua anima da letterato.
Durante la prima presentazione del libro nel 1992, il filologo Aurelio Roncaglia motiva così la lunga attesa per la pubblicazione:
“Abbiamo atteso tanto prima di tutto per i temi scottanti, sia dal punto di vista politico che erotico, che Pasolini tratta; in secondo luogo perché un’opera di una tale incompiutezza poteva anche nuocere all’autore. Ma non potevamo censurarlo. Anche Piero Gelli, direttore editoriale di Einaudi, ha ammesso di aver avuto qualche perplessità trattandosi di un’opera scomoda.”
Cinquecentoventidue pagine o veline (il tipo di carta utilizzata da Pasolini), per lo più dattiloscritte, invece delle duemila programmate che avrebbero dovuto raccogliere l’intera visione pasoliniana del potere.
Il 26 dicembre del 1974, tuttavia, come riferisce anche Roncaglia nella nota filologica all’opera, Pasolini si esprime in modo piuttosto preciso in merito al numero delle pagine:
“Nulla è quanto ho fatto da quando sono nato, in confronto all’opera gigantesca che sto portando avanti: un grosso Romanzo di 2000 pagine. Sono arrivato a pagina 600, e non le dico di più per non compromettermi”.
Il 10 gennaio 1975, sulla Stampa, il poeta ripete la stessa cifra al giornalista Lorenzo Mondo: «Seicento pagine abbozzate sulle duemila definitive». È la conferma della mancanza o addirittura della scomparsa di circa settantotto pagine (600-522) del dattiloscritto, quantomeno stando agli elementi certi a disposizione. Il numero indicato dallo scrittore è così preciso che la laconica spiegazione, nella stessa nota filologica di Roncaglia, secondo cui la cifra annunciata da Pasolini era un arrotondamento per eccesso, resta insufficiente.
Da Pasolini Massacro di un Poeta (Ponte alle Grazie 2015) allrights reserved

Il “caso Moro”, Sciascia, Mattarella e la Sicilia
di Simona Zecchi
Scriveva Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera nel 1982: «Si è parlato – e molti che non ne hanno parlato ci hanno creduto – della ‘geometrica’ perfezione di certe operazioni delle Brigate Rosse: e si è poi visto di che pasta sono fatti i brigatisti e come la loro efficienza venisse dall’altrui inefficienza. Arriveremo alla stessa constatazione – almeno lo spero – anche con la mafia.»
Già altrove lo scrittore siciliano era ricorso a rappresentare le due ‘forze’ – terrorismo e mafia – come motrici entrambe degli omicidi Mattarella (Piersanti, ammazzato il 6 gennaio 1980) e Reina (Michele, ammazzato il 9 marzo 1979). Scriveva in particolare il 7 gennaio del 1980 sempre sul Corriere:«Io sono stato tra i pochissimi a credere che Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, fosse stato assassinato da terroristi. Terroristi magari un pò sui generis, come qui ogni cosa; ma terroristi. […] Oggi di fronte all’assassinio del presidente della Regione Mattarella, quella mia ipotesi, che quasi mi ero convinto ad abbandonare, mi pare che torni a essere valida.» Giovanni Falcone, infatti, titolare della prima istruttoria sull’omicidio di Piersanti Mattarella aveva sin da subito indirizzato le indagini verso una pista nera per ciò che riguardava gli assassini materiali di cui chiese l’arresto nel 1986. Quella istruttoria culminò in una requisitoria depositata nel 1991 che poi non ebbe conferme giudiziarie ma che proprio recentemente ha di nuovo fatto capolino. Mattarella ha rappresentato in terra siciliana, per ciò che riguarda il compromesso storico fra PCI e DC, quello che Aldo Moro (con un percorso iniziato nel 1969 attraverso una sua “strategia dell’attenzione” verso il partito comunista italiano) è stato a livello nazionale, con tutte le specificità e le differenze che certo li caratterizzavano e che caratterizzavano le “due terre”: la Sicilia spesso per anni un mondo a parte, e il resto d’Italia. Una differenza che anche si inserisce nella questione del compromesso in sé a livello nazionale. Chi si è opposto a logiche criminali come Mattarella e Reina si era anche opposto a un sistema di potere più complesso e ampio. Nel caso di Mattarella parliamo -secondo quanto emerse allora e permane come sospetto per il momento oggi – di terrorismo nero oltre all’intervento di Cosa Nostra. Per quanto riguarda il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro – strage degli agenti annessa-, l’evento spartiacque per gli equilibri nazionali indicativi per Moro di un cambiamento nel Paese al quale dare inizio, si è trattato di terrorismo rosso. Il colore politico, è ormai giunto il momento di dichiararlo con coraggio, cambia soltanto in funzione di dinamiche ma non di resa, di risultati.
Cambiare approccio per ricostruire i cinquantacinque giorni del Caso Moro nella inchiesta da me condotta e culminata nel libro, “La Criminalità servente nel Caso Moro” ha significato certo attraversare quaranta anni di storia politico-criminale e di contesti politici nazionali e internazionali, ma non da ultimo ha inoltre significato raccogliere i fatti che conducevano verso quel filone, esaminarli in controluce ed esporli tutti in fila come se posti su un tavolo immaginario (anche se in realtà fisicamente è avvenuto proprio così), certo verificandoli. Lavorare su temi così complessi non può prescindere dall’analisi dei fatti e dei contesti insieme. Concentrarsi soltanto su uno dei due fattori rende il quadro intero sbilanciato nelle sue tinte. Così, la tavolozza che mano a mano ne è emersa non lasciava scampo: i vertici della criminalità organizzata e delle consorterie che la costituivano in quegli anni (attenzione non pedine o anche soltanto boss qualunque seppure di rilievo) hanno influito e operato nel Caso Moro, moltissimo. Non soltanto per ciò che riguarda le presenze di uomini della ‘ndrangheta accertate o ancora da accertare sul luogo della strage, Via Fani, dove alle 9.02 del mattino la raffica di fuoco incrociato è partita, ma anche per quanto riguarda la gestione del sequestro fino alla consegna di Moro morto in Via Caetani, riverso nell’abitacolo di una Renault 4 rossa, e per le connivenze tra frange della lotta armata allineate alle BR e la criminalità organizzata e comune. A parte, poi, va considerato l’aspetto forse più noto al grande pubblico: il ruolo di alcune organizzazioni criminali nel tentativo di liberazione dell’onorevole Moro. Aspetto questo che ricostruito da me interamente dall’inizio, compiendo tabula rasa su quanto scritto e raccolto sino a quale momento da altri, ha anche fatto emergere dettagli e aneddoti rilevanti e nuovi per la comprensione dell’Affaire tutto. L’insieme di questa distesa di elementi conducevano tutti in Calabria: la ‘ndrangheta, cresciuta nel corso degli anni all’ombra dei riflettori di una Cosa Nostra più ‘spettacolare’, infatti, rappresenta secondo quanto da me ricostruito la costante del Caso Moro e insieme la costante di altri eventi tragici che, come le ultime inchieste della Procura di Reggio Calabria certificano, ha attraversato questo Paese. Una costante operante quasi sempre con Cosa Nostra ma non necessariamente.
Durante il corso delle indagini che la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul caso stava svolgendo, ho seguito dunque un mio percorso investigativo parallelo supportato ovviamente dalla ricerca incessante e dallo studio degli atti passati e nuovi che come già svolto per un’altra inchiesta, quella sulla morte di Pier Paolo Pasolini, mi ha poi portato a sviscerare elementi inediti e anche alla ricostruzione di un contesto mai considerato prima in modo unitario. Fino a giungere agli anni della trattativa Stato-mafia così come la conosciamo, quella il cui processo di Palermo è da poco culminato a un primo grado di condanne e ad alcune assoluzioni (parziali o totali).
Il cuore di questo libro-inchiesta è costituito da due punti principali: da un lato la spiegazione del “mistero” del falso comunicato del lago della Duchessa, legato alla scoperta del covo di Via Gradoli il 18 aprile del 1978 nel bel mezzo del sequestro, e l’emersione di una nuova prigione in cui Aldo Moro è stato di passaggio durante la sua prigionia: un covo non lontano dal lago stesso nella Sabina fra il Lazio e l’Umbria, luogo legato a sua volta sia a elementi della lotta armata sia alla criminalità; dall’altro, lo sviluppo delle inchieste del generale Dalla Chiesa e il giudice Vittorio Occorsio sulle morti dei quali pesa l’ombra sia della mafia sia del terrorismo: entrambi, infatti, stavano indagando su una struttura riservata composta da parti della massoneria, della criminalità organizzata, consorterie politiche e della magistratura, e di elementi del terrorismo di destra e di sinistra. Nel libro, tra le altre cose inedite, viene per la prima volta pubblicato l’estratto di un verbale sconosciuto alle cronache e alle ricostruzioni sin qui svolte, un verbale che porta proprio la firma del Generale. Intorno a questi due punti cardinali della inchiesta vengono da me sviluppati ulteriori fatti e risvolti a essi collegati. La “geometrica potenza” invocata da Sciascia, espressione usata in un articolo sequestrato a Franco Piperno leader di Potere Operaio, e operativo presso l’Università della Calabria, si dispiega tutta qui.
Attraverso un metodo giornalistico che definisco “della piramide rovesciata” arrivo dunque al cuore del Caso Moro cercando di consegnare un pezzo di verità mancante di questo segreto usurato della Repubblica. Con le “prove” che un giornalista umilmente può portare.
Testo pubblicato sul Blog di La Repubblica “Mafie” di Attilio Bolzoni il 22 giugno 2018
Risposta di Pier Paolo Pasolini a Italo Calvino – 8 luglio 1974
<<Che degli altri abbiano fatto finta di non capire è naturale. Ma mi meraviglio che non abbia voluto capire tu (…) Io rimpiangere l’Italietta? Ma allora tu non hai letto un solo verso delle Ceneri di Gramsci o di Calderón, non hai letto una sola riga dei miei romanzi (…) Perché tutto ciò che io ho fatto e sono, esclude per sua natura che io possa rimpiangere l’italietta>>
– Da Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, in Scritti Corsari, apparso già in Paese Sera come “Lettera aperta a Italo Calvino: Pasolini, quello che rimpiango”
Pippo Fava: 5 gennaio 1984-2014
“Io ho un concetto etico di giornalismo. Un giornalismo fatto di verità, impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Se un giornale non è capace di questo si fa carico di vite umane. Un giornalista incapace, per vigliaccheria o per calcolo, della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori che avrebbe potuto evitare, le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze, che non è stato capace di combattere”.
L’inchiesta avocata a Donadio sulle stragi Falcone-Borsellino e il Protocollo Fantasma
di Simona Zecchi
Se tutti i giorni del primo dell’anno fossero illuminanti come questo sarebbe sempre un bel giorno per il giornalismo.
Questo pensiero, da puro apripista per un post di un blog personale, può sembrare poco modesto ma in realtà è una provocazione perché le vicende che hanno percorso quasi tutto l’anno appena trascorso, riguardanti l’inchiesta del titolo e il cosiddetto processo sulla trattativa stato-mafia hanno spesso rasentato l’onta del ridicolo e del puro depistaggio. E’ una provocazione anche verso giornalismo mainstream di oggi spesso poco incline al ragionamento e al collegamento dei fatti perchè scomodo oppure troppo fuori dai “canoni di pubblicazione”.
I Fatti dell’Anno. Vediamo un pò: ad inizio anno, l’erede di un fantasma di un’epoca che fu (e che sembra mai tramontare) si rifà vivo: il Corvo. Una prima lettera anonima inviata all’attenzione del Pm Di Matteo lo avvisa che è monitorato da alcuni ‘uomini delle istituzioni’. Ne seguiranno altre nel corso dell’anno. Sembra però un altro tipo di “corvo”, non un alimentatore di veleni tra le procure, ma forse un investigatore che non ha mai accettato le logiche annebbiate di certi processi e certe indagini le quali spesso rimangono appese a un limbo infinito oppure finiscono in assurde archiviazioni; il fantomatico scoop sulla ricomparsa dell’agenda rossa che in realtà era una parte di parasole rossa che emergeva tra i resti fumanti di una delle auto blindate del magistrato Paolo Borsellino (La Repubblica maggio 2013); le varie diatribe durante le indagini preliminari per il processo sulla trattativa, via via proseguendo con gli arresti in merito alle indagini sulla strage di Capaci che sembravano suggellare la sola mano mafiosa nell’attentato (secondo anche le dichiarazioni della procura di Caltanissetta) assunzione che poi invece fu smentita con la stessa inclusione nel registro degli indagati di “faccia da mostro” un ex poliziotto ormai in pensione il cui soprannome di tanto in tanto compariva nei vari filamenti dei misteri cuciti addosso allo Stivale (dalla protezione a Ciancimino Sr. alle morti dei due agenti Emanuele Piazza e Nino Agostino). Faccia da mostro ora ha anche un nome Giovanni Aiello, che il padre di uno degli agenti morti (Vincenzo Agostino) avrebbe riconosciuto come colui che comparve per cercare il figlio, quando non in casa, pochi giorni prima della sua morte. La sua e quella della moglie in cinta. In mezzo a tutto questo, l’improvvisa avocazione al Pm Gianfranco Donadio dell’inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, che già nel lontano ’93 e su mandato dell’allora PNA Grasso, stava svolgendo un’inchiesta solitaria e parallela. E poi: la scomparsa del collaboratore di giustizia Nino Lo Giudice a cui sono succeduti nell’ordine: due memoriali e un nuovo arresto. Memoriali che sancivano la piena ritrattazione dell’ex pentito sulle precedenti dichiarazioni, le quali puntavano le accuse su una parte della magistratura antimafia ma soprattutto su Donadio. C’è un altro collaboratore ad oggi ritenuto affidabile da ben 9 procure nazionali più una straniera (checché ne dica Nando dalla Chiesa che lo ha attaccato in ben due articoli- uno suo sul “Fatto Quotidiano” e un altro in cui era intervistato dal sito Stampo Mafioso): Luigi Bonaventura. Bonaventura sin dal 2007 collabora con i magistrati e svela crimini e misfatti anche politici che aveva raccontato prima ai giudici e poi ai media, così come la “tecnica di avvicinamento” di soggetti appartenenti alla ndrangheta (e non solo) per indurre i “buoni” collaboratori a ritrattare, nonché il “programma” sui falsi pentiti. Bonaventura ha ricostruito con la sottoscritta in un articolo per Antimafia Duemila (qui) , quello che può succedere a un collaboratore che vuole fare solo il suo dovere mentre è sotto il programma di protezione.
(nella foto Luigi Bonaventura)
Le conseguenze. E di nuovo come contorno a tutto questo restano le conseguenze che non sono entusiasmanti: l’inchiesta di Donadio su eversione- nera-mafia e istituzioni come concorrenti tutti nelle stragi di 20 anni fa, sfuma per sempre; la guerra tra procure se possibile diventa ancora più aspra, i giochi di potere e di complotto interni alle stesse non si fermano mai, le intercettazioni fra l’ex Ministro Mancino e il due volte Presidente della Repubblica Napolitano vengono distrutte come conseguenza del conflitto di attribuzione da lui stesso sollevato l’anno precedente (dimostrando cosi che qualcosa da nascondere l’avesse quanto meno, come controcanto alle sue continue chiamate a svelare tutte le verità della nostra storia…). Intanto l’avvocato Rosario Pio Cattafi personaggio che vive, stando alle indagini e alle accuse nella requisitoria, fra eversione nera, istituzioni più o meno deviate e massoneria, viene condannato proprio a fine anno 2013 nel processo “Gotha3” con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Insomma non è un bell’anno né per l’antimafia (che tra l’altro si lascia “sfuggire” la possibilità di catturare Matteo Messina Denaro ma non era certo la prima volta: da Nitto Santapaola passando per Riina e Provenzano, la storia continua a ripetersi) né tanto meno per la mafia militare: tra sequestri di beni per milioni di euro, condanne e arresti a iosa. E’ tempo di riorganizzazioni e di intese.
Le inchieste. Poi proprio in questi giorni esce un libro di Walter Molino (giornalista di “Servizio Pubblico”): “Protocollo fantasma – Dossier silenzi e segreti di stato: strategia della tensione al tempo delle larghe intese” (Il Saggiatore, 2013) che non è l’unico sulla questione (il documento segreto ma conosciuto ormai da tutti su uno speciale protocollo fra DAP e Servizi segreti dal quale sono esclusi gli organi inquirenti ufficiali alias la magistratura): nel 2012 infatti la seconda edizione del libro di Maurizio Torrealta e Giorgio Mottola “Processo allo Stato” (Bur edizioni, novembre 2012) ne parla ampiamente. Ma il libro di Molino fa un altro lavoro (direi ottimo, a parte qualche licenza da romanziere in alcune parti: ma si sa alcune cose possono essere a volte solo raccontate come “fiction”) di collegamento fra tale documento e alcuni fatti che hanno lastricato le vie dei misteri italiani sulle vicende di mafia e non solo: dalla gestione della cattura di Provenzano, preceduta dalla vicenda Macrì-Cisterna-Vigna-Grasso e la prima tentata resa di zio Binnu nel 2003 (o asta al miglior offerente visto che lo Stato anche per ragioni politiche era pronto a pagare un mediatore 2 milioni di euro per farlo suo dopo quasi 40 anni, allora, di fuga protetta o latitanza), fino appunto alla sempiterna trattativa stato mafia che in fondo include tutte queste vicende, sono parti di un tutto. All’interno anche una ricostruzione della vicenda della fuga di Lo Giudice e l’inchiesta avocata a Donadio. Sono esposizioni di fatti e in questa parte Molino non collega apertamente l’esistenza del protocollo con la gestione del Lo Giudice. Però se è lecito ancora ragionare mi ha appunto illuminato su un punto cui sono giunta avendo seguito tutto e avendo parlato del doppio livello e di doppio commando nelle stragi di capaci (soprattutto) e Via D’Amelio partendo da Portella della Ginestra in un’intervista a Stefania Limiti sul libro uscito ad Aprile di quest’anno: “Doppio Livello – come si organizza la destabilizzazione in Italia” (Chiarelettere, 2013). Libro quindi che già prima di Molino e in maniera storico-giudiziaria dimostra come certe operazioni “sotto falsa bandiera” possano aver contribuito a cambiare gli eventi del nostro paese attraverso stragi depistaggi et similia. Alla presentazione del libro c’era per la prima volta il magistrato Donadio che pur non rilasciando specifiche dichiarazioni con la sua presenza ha firmato la sua esposizione (legittima perché comunque titolare di un’indagine e non lesiva di alcuna rilevazione d’ufficio). Il magistrato come spiego bene in quell’articolo aveva già parlato dell’inchiesta in occasione di un’intervista per Rainews24 il 17 maggio 2012 ed era quanto meno evidente che l’inquirente non avesse molti amici a sostenerlo in questo lavoro. (Prova ne fu la fuga di notizie sulla sua relazione alla DNA con novità che riguardavano faccia da mostro soprattutto. Fuga di notizie perpetrata da due giornali “Il Sole24” e “L’Ora della Calabria” il 12 settembre scorso. Dei due giornali solo quest’ultimo tuttavia ha subito perquisizioni e indagini dalla Procura). Ma torniamo al Lo Giudice: la domanda, dopo quella fuga di notizie e prima ancora con la fuga “fisica” dell’ex collaboratore, come dire… sorgeva spontanea: cosa poteva mai sapere un boss non di grande calibro (ma vicino ai Pelle-De Stefano) con la trattativa stato-mafia? Donadio lo aveva interrogato in merito proprio per la sua inchiesta, probabilmente perché il più “fresco” tra i collaboratori, che però come adombra un pò Molino pare che avesse iniziato già a collaborare in maniera non ufficiale prima. Fresco e quindi eventualmente più al corrente degli ultimi sviluppi e di qualche confidenza legata a fatti che tarvalicano i meri crimini della “mamma”. Vediamo cosa prevede questo benedetto Protocollo fantasma nel dettaglio? Scrive Molino:<< (…) cosiddetto Protocollo fantasma, un accordo vincolato dal segreto di Stato tra il Dap e l’ex Sisde per la gestione dei più importanti e pericolosi detenuti in regime di massima sicurezza. Un circuito informativo parallelo che ha consegnato di fatto le carceri ai servizi, tagliando completamente fuori la magistratura.>> Di questo protocollo, come continua Molino, sappiamo tutto (“interrogazioni parlamentari e inchieste giornalistiche”) ma nessuno lo ha mai visto, appunto un protocollo fantasma ma operativo. Nel libro i protocolli sono due: uno riferito al dossier ricevuto dai magistrati della procura di Palermo dal “Corvo2”, l’altro quello specifico stilato e approvato da membri interni al Dap e istituzioni sulla gestione di detenuti importanti che ha anche un nome “leggero”, quello di farfalla. La farfalla si posa e non lascia tracce, mai nome fu più azzeccato.
(nella foto Gianfranco Donadio)
Conclusioni. Lo Giudice viene arrestato nel 2010 e dopo pochi giorni si pente, come scrive giustamente Molino ricostruendo la sua storia dopo l’arresto. Cosa gli succede a un certo punto dopo che alcuni fatti da lui dichiarati erano stati riscontrati dalle indagini? Chi subentra e manipola “tagliando completamente fuori la magistratura” fino al punto da non sapere che già collaborasse (e in che modo poi?), fino a sporcare i lembi di chi indaga su infiltrazioni e doppi livelli? Che il protocollo sia ancora utilizzato?
Una piccola illuminazione quest’ultima in un giorno che accende l’anno che verrà: in cui non mancheranno nuovi corvi, nuovi depistaggi e clamorosi “scoop” o notizie sottratte agli inquirenti senza però mai avvicinarsi alla verità. C’è rimasto solo il ragionamento (e su un blog personale, un giornale per carità…!).
“Bitter Spring”: Understanding Ignazio Silone
articolo uscito su I-Italy.org nel 19/10/2009
An interview with Stanislao G. Pugliese, Professor of History at Hofstra College and author of “Bitter Spring: A life of Ignazio Silone.” The controversial Italian writer—loved and hated in his country by anti-communists and anti-fascists alike—is studied in this book from historical, literary, and human perspectives.
After presenting his new book around the world in several occasions, on October 1, 2009, Professor Stanislao G. Pugliese brought it before a wide audience at the Casa Italiana Zerilli-Marimò at NYU. Also participating was Maria Paynter, Professor at Hunter College, who assisted him in his research on Silone. They answered several questions from the public and from Prof. Stefano Albertini, Director of the Casa Italiana.
The topic that especially interested the public was the case of Silone’s alleged role as a spy for the Fascist regime against the Communist Party. Considering Silone’s multifaceted life and experiences, “why shouldn’t we believe he was a spy?”, as someone in the public inquired. Professors Pugliese and Paynter explained that this last case broke out very recently, in 1996 (Silone died in 1978)”, and considering all the contradictions found even in the authentic documents that the Italian historians found regarding his “spying”, a more impartial judgment should be applied. Furthermore, it is Silone’s values and his contributions to history and society that are really relevant. During the event, information about many aspects of Silone’s life was offered by screening an interesting documentary by Italian journalist Giovanni Minoli from the RAI Television series “La Storia Siamo Noi.”
Before the event at Casa Italiana, we had the opportunity to meet Stanislao G. Pugliese and discuss his book (an excerpt of this conversation is available in audio here.)
“I didn’t actually chose it; in a sense, it chose me” he said. It was upon accepting the 2000 Silone Prize for his book “Carlo Rosselli: Socialist Heretic and Antifascist Exile” (Harvard College, 1999)—that Puglese realized that there weren’t any biographies of Silone in English, and decided to write one himself.
Bitter Spring: A Life of Ignazio Silone (Farrar, Straus and Giroux, New York 2009) gives a complex, all-round picture of Ignazio Silone’s works, values, and life. But it is intended as the work of an historian, not “just” a biographer. “In Italy, biography is not considered a high scholarly or literary form. In America, most people get their history from biographies. But I noticed that many biographies in America are 700, 800 or even 900 pages long. The biographer throws in everything, including the kitchen sink, to ‘prove’ that they really really ‘know’ their subject. I am more modest: I do not claim to have written the ‘definitive’ biography of Silone nor do I claim to have solved the latest ‘caso Silone.’ But I also like to think that this is more than a biography: that in a way it is an homage to a lost world of peasant culture in the ‘Mezzogiorno’ that no longer exists.”
Ignazio Silone was born Secondino Tranquilli in 1900 in the Italian region of Abruzzo; several of his novels are set in his hometown, Pescina dei Marsi, and are dedicated to the struggle of the Abruzzese peasants against landlords and officials. Secondino lost most of his family during the terrible earthquake that struck Abruzzo in 1915—a ‘bitter’ connection to what happened in the same region a few months ago (see the excerpt from his book Emergency Exit that i-Italy republished last April as a warning against what Silone called the “political calamity” that followed the “natural cataclysm.”) He became a writer only during his exile in Switzerland and after being expelled from the Communist Party.
His three most famous novels, Fontamara (literally “Bitter Spring”), Bread and Wine and The Seed beneath the Snow—all set in Pescina—made Silone’s popularity soar abroad. In the 1930s and 1940s, he was the most popular Italian writer in the United States; in September 1937, the English translation of Bread and Wine beat out John Steinbeck’s The Grapes of Wrath as Book of the Month selection. In Italy, on the contrary, he was rejected by the literary establishments because both his subject and his style were not considered “proper.”
“Silone should be of interest to contemporary Americans for several reasons,” says Pugliese. Today, in the current ideological moment, it might indeed be beneficial for Americans to understand the life and work of a man who was hunted by the Fascists and hated by the Communists. The problem is, according to the author, that in America the facts contained in this biography could be viewed as too old, whereas in Italy, given the present political situation, they could be misinterpreted. Silone in fact, did abandon the Communist Party and even worked against it, but he always remained an anti-Fascist activist.
And today, just as it happened several decades ago, the political controversies that made up the many “Silone affairs” do not allow his figure as a writer to come out properly, neither in his Italy nor in the United States.
There are several “Silone affairs,” as Pugliese explains. “One is the scandal of his lack of recognition in Italy: why was Silone so well known and read abroad but disparaged by literary critics in Italy?” Another is the controversy about his alleged ‘spying’ for the CIA against the Communists. In reality in the 1940s he worked with the OSS (the Office of Strategic Service, forerunner of the CIA) to end Fascism and the Nazi occupation of Italy. Much later, in 1968, when Silone learned that the Ford Foundation was laundering money from the CIA to his journal Tempo Presente, he closed down the journal with much bitterness and sorrow.
The latest “caso Silone” exploded in 1996, when Dario Biocca uncovered letters Silone had written to a police official in Rome in the 1920s. It is a controversial issue. “Although some of the letters were undoubtedly written by Silone, some are definitely written by someone else. There is also the question as to whether Silone was writing these letters to help his brother Romolo, arrested by the Fascists in 1928.” Even the case of his alleged homosexuality has been brought up, due to his relationship with Guido Bellone, a policeman working for the Fascists. However, Pugliese asserts: ”Dario Biocca and another historian have implied that it is possible that Silone was blackmailed… but there is no evidence of it; I think this is just speculation.”
History’s role is to connect interpretation to facts in order to separate distorting memories from good ones, and “personal memories can often picture reality in different ways, as it happened in regards to Silone: both on the left or on the right, everybody had their own opinions about Silone.
Thus Silone was and remains a controversial figure? His biographer’s conclusion is a resounding yes: “Even now, in Italy, on the right they praise him as someone who refused Communism without looking deeper into his refusal.”
“Strategia della delegittimazione”: chi tocca le trattative brucia
articolo pubblicato su Antimafia2000 il 29/10/13
di Simona Zecchi
Antefatto. Non è storia di oggi perché uscì già il 17 maggio del 2012 da un’intervista di Corradino Mineo al pm della DNA Gianfranco Donadio (foto) (allora procuratore aggiunto della PNA a Salerno). Intervista presente per la visione completa nel canale Youtubema che vale la pena trascrivere in parte, alla luce dei nuovi elementi di indagine emersi.
Così Donadio: ”Il Pm Tescaroli che ha sostenuto l’accusa contro gli imputati, nel corso della requisitoria ( sentenza d’appello del 7/7/2000 Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, ndr), si occupò di un particolare molto atipico riferito all’attentato. Ossia guanti di gomma e collanti incompatibili con la metodologia degli attentatori che minarono il cunicolo (il livello sotto il manto stradale, ndr) utilizzando attrezzi molto pesanti come guanti da lavoro.” “Il Pm parlò all’epoca – continua Donadio – “di rafforzamento della carica. I tecnici esplosivisti si riferiscono al rafforzamento con il termine esplosivo nobile che rende più efficace l’effetto di devastazione che venne provocato da circa 500 kg di esplosivo non particolarmente nobile”. E ancora “A Capaci c’erano due bombe”.
I Fatti. Dopo la nuova svolta investigativa della procura di Caltanissetta sulla strage di Capaci, intanto, forse non è più possibile mettere in dubbio il supporto di un’altra mano (quella dello Stato) oltre a quella mafioso-militare per l’organizzazione dell’attentatuni che suggellò l’ultima trattativa. E per la quale Paolo Borsellino vide accelerare il corso della propria morte in pochi giorni. Al vaglio del nuovo filone d’indagine come da notizia dell’8 ottobre scorso, infatti, ci sarebbe l’eventuale ruolo di Giovanni Aiello (agente di polizia in pensione dal volto deturpato) e anche quello di una tale Antonella.
E’ del 20 ottobre scorso poi la notizia dell’arrivo di certo esplosivo che sarebbe stato destinato all’ex pm Antonio Ingroia, fatto rivelato da un collaboratore di giustizia di ‘ndrangheta, Marco Marino, il quale sarebbe stato avvicinato da alcuni mafiosi di cosa nostra mentre in detenzione nel carcere Pagliarelli di Palermo tra il 2010 e il 2011. Sono poi cose note le minacce e gli avvertimenti rivolti al pm Di Matteo e agli altri sostituti che si stanno occupando della Trattativa di cui sono in corso le udienze.
Ma per capire questa storia di calcolata distruzione del pool che cerca di scoprire la verità di quelle stragi bisogna seguire un percorso narrativo a ritroso. Un’inchiesta pubblicata quest’anno dalla giornalista Stefania Limiti dal titolo “Doppio Livello” (Chiarelettere, 2013) aveva suscitato qualche polemica sia nei confronti della stessa giornalista che del settimanale che per primo ne pubblicò la recensione (“Il Venerdì” di Repubblica) e il suo autore Piero Melati, da parte proprio della procura di Caltanissetta. Nel libro viene spiegato lo schema sotto ‘falsa bandiera’, ovvero l’utilizzo di una tecnica di origine militare, accostata alle operazioni di camuffamento, come elemento sempre presente nelle dinamiche delle stragi italiane. Allo schema vengono ricondotte le stragi che partono da Portella della Ginestra e arrivano a Capaci, passando per Piazza Fontana. Il sostituto Donadio, sempre schivo nelle apparizioni televisive o restio alle interviste tout court (come se questo possa costituire elemento di gravità, ma oggi alcuni titoli di giornale suggellano la decisone in tal senso del procuratore Messineo sugli interventi mediatici dei giudici) aveva partecipato alla presentazione romana del libro. Da quel giorno gli attacchi interni alla procura antimafia, o ad essa esterni, si susseguono come ad effetto domino.
A giugno un fatto smuove la lenta fissità delle notizie estive: la fuga dalla località protetta nelle Marche del pentito di ‘ndrangheta Nino Lo Giudice, fuga accompagnata da un primo memoriale e rilanciato da un secondo ad agosto, il tutto a distanza di due mesi. Anche Lo Giudice nei suoi precedenti interrogatori, prima di ritrattare pubblicamente avrebbe parlato dello stesso uomo (Aiello), ora iscritto come indagato per strage, e di un’altra persona (Antonella, di cui si sta verificando l’identità). I due memoriali accompagnati da video amatoriali non sortiscono entrambi lo stesso effetto ma ottengono una cosa fondamentale: l’inquinamento sulla credibilità di Lo Giudice. A settembre, sul sito di cronaca e attualità, “fanpage.it”, il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura, ex reggente della cosca Vrenna-Bonaventura (lo stesso che denunciò di recente il tentativo da parte della ‘ndrangheta di attentare alla vita dell’attore Giulio Cavalli), parla già di una commistione tra politica e mafia per screditare i giudici, svelando i retroscena della strategia dei finti pentiti. Fatti di cui aveva parlato in passato agli inquirenti e ad alcuni organi dello Stato: un filo rosso che lega ‘ndrangheta, cosa nostra e pezzi dello Stato, una commistione che oggi acquista una grande rilevanza alla luce dei recentissimi eventi e la cui forza viene confermata proprio dal racconto a ritroso di questi eventi.
Bonaventura, non è più un mistero ormai, si trova a Termoli nel Molise, località che anche questa dovrebbe essere protetta. Località protetta, secondo il programma di “Servizio di Protezione Centrale”, dovrebbe significare identità protette e non protezione fisica costante: una cosa dovrebbe sostituire l’altra. Ma Bonaventura non ha né l’una né l’altra, nonostante il falso cognome sul citofono. E nonostante la buona volontà, a detta del pentito, del nuovo direttore del Servizio. Termoli “dove la gestione di mandamenti occulti da parte dell’organizzazione criminale ‘ndrangheta”- come afferma Luigi Bonaventura – è pane quotidiano ma non fatto quotidiano: la stampa ne parla poco o punto. Proprio Termoli, a pochi chilometri da dove era stata mandata la collaboratrice di giustizia Lea Garofalo dal programma di protezione, Campobasso (la cui identità fu invece scoperta dal marito che la sequestrò e uccise nel 2009 a Milano).
Bonaventura legge i memoriali lasciati da Lo Giudice confrontandoli a quelli video, rilasciati a sintesi degli scritti, come se fossero una mappa. Una mappa che lui conosce bene: ne interpreta i messaggi fuori riga, le incongruenze e le contraddizioni che destano più di un sospetto in questa plateale mossa strategica probabilmente mirata a far saltare un percorso che l’ormai ex pentito Lo Giudice stava compiendo. Bonaventura conferma all’autrice di questo articolo quanto segue: <<Del piano in corso sul Lo Giudice avevo già riferito agli inquirenti, nome che feci tra gli altri come quello di Antonio Di Dieco il quale, secondo il falso pentito Francesco Amodio, che mi avvicinò la prima volta, era disponibile a far parte del piano>>. (Antonio Di Dieco ha ricevuto recentemente dal GIP di Roma, Cinzia Parasporo, una ordinanza di custodia cautelare in carcere). Di Dieco, infatti, era già indagato per presunte false dichiarazioni nei confronti del Lo Giudice. In questi giorni lo stesso Cisterna è sotto il fuoco del Tribunale della Libertà di Roma per gli scambi poco opportuni tra lui e il difensore di Di Dieco, Claudia Conidi.
I nomi e i fatti che Bonaventura ha già rivelato agli inquirenti in tempi non sospetti (nel 2011) sono tutti segnati da appunti da lui raccolti e da noi visti, comunque già apparsi nelle sue interviste video. Scritti pieni di memorie e riflessioni sui fatti che mano a mano gli accadevano: abbordaggi, avvicinamenti e minacce anche da parte di uomini che erano preposti alla sua protezione. <<I nomi fatti dal Lo Giudice – continua Bonaventura – sono quasi tutti gli stessi fatti a me tra magistrati e funzionari, la loro strategia è quella di farti dire nomi che appartengono alla stessa area di provenienza: Crotone>>. <<Fatto – continua Bonaventura – che va collegato con Lo Giudice in quanto gli stessi funzionari e magistrati avevano sentito il pentito nei vari procedimenti.>> Il funzionario Renato Cortese, il magistrato Pignatone, nomi fatti dal Lo Giudice che si collegano a queste dichiarazioni. Questo punto è molto importante perché sottolinea la fine peculiarità della strategia di delegittimazione portata avanti nei confronti dei pentiti e di alcuni magistrati. Appurare se e quali di essi è giustamente tirato in ballo o meno dal Lo Giudice è compito delle procure che stanno seguendo il caso, come ha dichiarato a chi scrive in una precedente intervista il procuratore capo di Reggio Calabria De Raho. Delegittimazione o tentativi di corruzione dunque per tornare alla vita di prima magari da finti pentiti protetti dallo Stato, come ha denunciato lo stesso Bonaventura. Patto che il Bonaventura non ha accettato andando incontro a un rischio quotidiano per lui e la sua famiglia sapendo anche lui che chi tocca certi livelli, nel suo caso testimoniando, brucia. In fondo per questo ha deciso da un po’ di tempo ormai di non celare più la località in cui si trova: è inutile e forse paradossalmente più sicuro.
Tra gli elementi che screditerebbero le testimonianze rese nei memoriali dal Lo Giudice, secondo la lettura e l’esperienza di Bonaventura, vi è la dinamica delle pressioni che avrebbe ricevuto l’ex pentito Lo Giudice in fuga da questo o quel magistrato. Pressioni che, leggendo i memoriali, Lo Giudice denuncia in modo più crudo proprio verso il magistrato Gianfranco Donadio. Donadio, era stato a suo tempo incaricato da Piero Grasso di svolgere indagini sulle stragi del 92-93 ed era arrivato a uno schema particolare di compartecipazione nelle stesse, un doppio livello militare e mafioso. A Donadio poi è stata avocata l’indagine sulle stragi (altro successo ottenuto da questo sottile piano di delegittimazione). Proprio qualche giorno fa davanti alla prima commissione del CSM, il pm ha difeso il proprio operato affermando di non avere alcuna responsabilità nella fuga di notizie sulle indagini (nella quale sono coinvolti due quotidiani: “Il Sole24” e L’Ora di Calabria) né di aver mai oltrepassato i termini della delega alle indagini ricevuta da Grasso. Tra i magistrati che avrebbe dovuto delegittimare Bonaventura non vi era Donadio, come risponde su domanda il pentito, ma la dinamica sottesa a questi eventi è tanto più importante a confermarlo: al pentito non costerebbe nulla dire anche ciò che non sa e invece riferisce solo ciò che sa e pensa:
<<Quello che riferisce Lo Giudice, la dinamica che si evince dai suoi racconti è totalmente non credibile>> – continua Bonaventura – << I luoghi deputati ad incontrare i magistrati durante i colloqui e le deposizioni sono assolutamente controllati, monitorati e registrati: ci sono poliziotti, i legali che assistono, ecc. Comunque tutte persone terze che potrebbero avere un ruolo di testimonianza nel caso si verificassero episodi di minaccia simili. A me non è mai successo, e il tutto è riscontrabile dai verbali: c’è una precisa volontà in tutta questa storia di attaccare la magistratura, l’unica invece che oggi può fungere da punto di riferimento e che per me rappresenta la vera essenza dello Stato>>.
Fatto invece fondamentale nella disamina del tutto, secondo sempre il Bonaventura, sarebbe il resoconto dell’abbordaggio cui sarebbe incorso il Lo Giudice e di cui fa riferimento nel memoriale: <<Qui Lo Giudice sembra che inconsapevolmente o meno si contraddica; essere avvicinato da persone esterne in un luogo cosiddetto protetto è proprio quanto è accaduto a me>>. E’ qui che le contraddizioni sono importanti. Certo resta da capire ancora quale parte detta da Lo Giudice è vera e quale no. Ma nel piano di delegittimazione la confusione e la messe di accuse uguali e contrarie sono parte della strategia. D’altronde lo stesso avvocato Giuseppe Nardo che nei memoriali Lo Giudice sembrerebbe nominare come suo, destituendo l’altro, in una intervista di fine agosto all’autrice di questo articolo aveva dichiarato con molta evidenza come lo stesso fatto e quanto dichiarato denunciassero “una grave situazione di frattura all’interno delle correnti di magistratura della Procura di Reggio, fatto che certo non rassicura i cittadini”. Insomma derubricare tutto a una lotta interna alle procure sembra il mantra che serve a confutare tutto.
Bonaventura dichiara anche un fatto mai prima reso noto ad alcun organo di stampa, che seppure è solo una sua percezione quanto meno lancia un allarme sul servizio effettivo di protezione che dovrebbe ricevere Bonaventura:<<Ho avuto anche il sospetto che tra i personaggi che si accompagnavano con i De Stefano-Tegano agli abbordaggi in cui mi hanno coinvolto ci fosse anche qualcuno dei servizi>>.
Per il superpentito Bonaventura, che ha collaborato ad oggi con ben 9 procure nazionali e una internazionale, attestandone sin qui l’attendibilità, la mossa di Lo Giudice è <<una mossa preparata a dovere e con grande anticipo>>, che demolirebbe la reazione di sdegno e mal sopportazione raccontata dal Nano nei memoriali (così viene anche chiamato Lo Giudice). <<Se così fosse>> – continua Bonaventura – <<allora lo racconti agli inquirenti, lo racconti subito non ti prepari a dicembre, o forse prima, per poi uscire a giugno>>.
C’è inoltre un importante distinguo, quasi la notizia di questo articolo, che fa Bonaventura riferendosi a una sua passata intervista resa a Rainews24 nel 2012 sempre riguardo al piano di delegittimazione. Nell’intervista fece alcuni nomi di politici che sarebbero stati obiettivo di delegittimazione (Berlusconi, Alfano, Maroni). Il superpentito ci tiene oggi a precisare senza riferirsi a nessun politico in particolare che la delegittimazione politica come piano strategico è soprattutto elemento di ricatto alla corrente interna di quegli stessi partiti che in larga parte appoggiano o hanno appoggiato le ‘ndrine. Era ciò che voleva dire in quei pochi minuti ritagliati nell’intervista. E’ Bonaventura stesso ad affermare che quando si trovava in carcere riceveva indicazioni di voto specifiche. Dunque il nome di questo o di quel politico, viene fatto con la consapevolezza che serva a una o più correnti avverse nello stesso partito. Insomma utilizzare alcuni pentiti sensibili a certi richiami, e magari anche stanchi di lottare in un sistema che spesso protezione non dà, per dare avvertimenti al proprio avversario di corrente.
Lasciare Termoli e il peso degli occhi addosso non è stato più facile che entrarvi, perché nel frattempo si è potuta constatare la condizione in cui vivono Bonaventura e i suoi familiari, che lo hanno seguito in questa lotta contro un mondo ormai rinnegato. Luigi ripete spesso le parole “dissociato” e “collaboratore” nel suo discorso, perché insieme i due termini convogliano in quello unico di pentito troppo spesso abusato. Chiude il collaboratore con un messaggio che è quasi un appello:<<L’arma dei collaboratori di giustizia potrebbe essere più efficace se anche la politica facesse il proprio dovere: se desse gli strumenti giusti al programma di protezione e non ostacolasse l’opera dei veri collaboratori che vogliono dare un contributo alla giustizia riparando i fatti criminosi commessi nel proprio passato>>. Bonaventura è in attesa di vedere accettata la sua richiesta per la protezione in luogo diverso dal territorio italiano così come quella ripetuta più volte, ma senza esito, di una scorta.











