Le parole di Graviano, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta: analisi dei fatti e i loro collegamenti
Analisi & Fatti di Simona Zecchi

Capaci (immagini wikipedia)
Operazione San Valentino. No, non si tratta di un’idea per la passata festa degli innamorati, ma del nome di una operazione di polizia contro Cosa Nostra che nell’aprile del 1981 portò all’arresto di alcuni mafiosi tra cui anche Vittorio Mangano l’ex stalliere e mafioso che lavorava per Silvio Berlusconi (numero di tessera P2 1816, gruppo 17, settore editoria come recitavano le liste ufficiali dell’associazione segreta capeggiata in Italia da Licio Gelli fuoriuscite sempre nel 1981 dalla perquisizione eseguita a Villa Wanda ad Arezzo).
E’ il 1984 quando il quotidiano palermitano L’Ora anticipa i contenuti di alcune indagini allora in corso che riguardano l’ex sindaco del sacco di Palermo, Vito Ciancimino, legate proprio alle indagini e agli arresti che portarono a quell’operazione qualche anno prima. E’ il rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S del 13 aprile 1981, infatti, a riferirvisi, utilizzato poi anche nel processo contro Marcello Dell’Utri (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e la cui pena ha espiato in cinque anni anziché 7 per concessione della libertà anticipata) tuttora indagato sia a Palermo che a Firenze sempre per mafia, nel capoluogo fiorentino è indagato insieme al suo ex datore di lavoro Berlusconi. Ed è da qui che tutto ha inizio, dal punto di vista criminal-giudiziario e anche mediatico. Quasi un bollettino “di guerra” di fatti e misfatti che portano sino ai due processi oggi in corso a Palermo (il secondo grado del processo trattativa Stato-Mafia) e a Reggio Calabria (il processo ‘Ndrangheta stragista). Sono i due processi-cuore del Paese Italia, a loro volta collegati ad altri procedimenti tuttora in corso come quello di Caltanissetta, contro Matteo Messina Denaro accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, e quelli riguardanti il presunto depistaggio di Via D’Amelio sempre a Caltanissetta, portato avanti – secondo indagini e processi in corso appunto – da ex poliziotti e magistrati (celebrato questo a Messina). E’ una matassa intricatissima i cui fili sebbene stentino a dipanarsi cominciano ad essere quanto meno individuati.
In quel servizio de L’Ora emersero rapporti fra il gruppo di una famiglia con affari a Milano (i fratelli Bono) e la Inim, società immobiliare che tentò di acquisire la società Venchi Unica dopo il fallimento del Gruppo Sindona. E’ una storia questa che da sola meriterebbe un approfondimento ma che al momento lasciamo così. E’ dalle intercettazioni di quelle indagini che si scoprono i rapporti personali fra Marcello Dell’Utri e Vittorio Mangano, trafficante di stupefacenti operativo a Milano, e parte della cosca mafiosa capeggiata da Rosario Spatola. Fu la prima volta che la stampa ne scrisse, poi più nulla, fino alla famosa (ma non per tutti) intervista che il giudice Paolo Borsellino il 21 maggio 1992 rilasciò ai giornalisti francesi Pierre Moscardo e Fabrizio Calvi. L’intervista fu trasmessa soltanto nel 2000 da Rainews 24 e non per intero, ma nel 1994, il settimanale L’Espresso ne aveva pubblicata la trascrizione. Nella intervista, che precede di soli due giorni la strage di Capaci, Paolo Borsellino fa intendere ai giornalisti – consegnando loro delle carte – che vi erano delle indagini aperte sui legami fra imprenditoria del Nord e Cosa Nostra e pressato dalle domande dei giornalisti, ma senza poterlo concretamente affermare, fa capire come il riferimento di quelle indagini fosse proprio il legame fra Mangano e Dell’Utri (e di conseguenza Berlusconi). In quelle vecchie indagini della Criminalpol di Milano, invece, la cui intestazione negli allegati al rapporto recita proprio così:
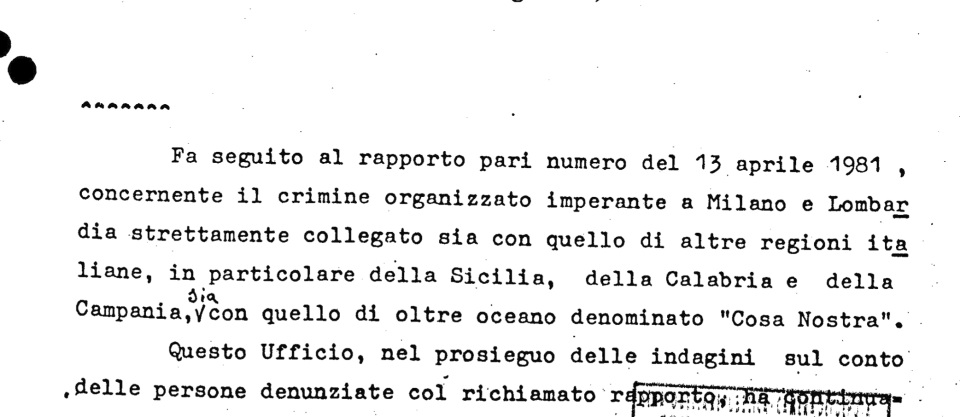
Allegato al rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S del 13 aprile 1981 (Fonte Commissione Mitrokhin)
è incestato l’origine di tutto ciò che andò a svilupparsi poi.
Secondo una notizia apparsa su Il Fatto Quotidiano a luglio del 2019 il giornalista di origini italiane, Fabrizio Calvi, è stato oggetto di rogatoria internazionale da parte della Procura di Caltanissetta per essere sentito come testimone proprio su quella intervista. Il 23 luglio 2019 Calvi rilasciò una intervista a sua volta sul Blog Mafie di Repubblica e disse:”Certamente Mangano è al centro della conversazione. In quel momento si trovava in galera ma era uno sconosciuto. Berlusconi non era ancora al centro dell’attenzione pubblica come poi lo sarà dopo, quando fece il suo partito e divenne presidente del Consiglio. Era un industriale non ancora al centro delle inchieste delle procure siciliane quanto di quelle del nord, dove era già scoppiata Tangentopoli. Ecco, Borsellino voleva evidentemente che fosse resa pubblica la storia di Mangano, accennando molto brevemente ad una inchiesta aperta anche a Palermo su Berlusconi, inchiesta di cui non si è saputo poi più nulla, per quanto io ne sappia. Penso che avrà senz’altro valutato i rischi delle sue parole per le indagini, se non per la sua stessa vita”.
Il giornalista tende a escludere che la intervista da lui fatta a Borsellino potesse essere stata la causa scatenante in sé dell’accelerazione della morte del giudice ma aggiunge, in merito alle carte consegnate loro da Borsellino:
“Si trattava dell’elenco di tutti i casi giudiziari nei quali era invischiato Berlusconi, tutti documenti giudiziari pubblici. Quando andai a cercarli mi resi conto che li avevo già quasi tutti nel mio archivio. Fu un gesto di cortesia e di fiducia che ancora mi commuove”.
Il 1981 è l’anno fondante di tante storie perché è proprio in quell’anno che il giudice Giovanni Falcone scopre a Palermo, mentre indagava su quello che si sarebbe poi rivelato come il finto sequestro Sindona, i locali della loggia Camea dove spunta anche la tessera di iscrizione dell’ex comandante militare di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli residente nella seconda metà degli anni 70 nel capoluogo siciliano (condannato a diversi ergastoli ora agli arresti domiciliari). Il 1981 è l’anno della scoperta della esistenza – già dal 1965 – della P2 dove Berlusconi entra il 26 gennaio 1978 e sembra ne esca il 31 dicembre 1982. Il 1981 è inoltre anche l’anno dell’omicidio di Stefano Bontade quando lo scettro di Cosa Nostra passa a Totò Riina mentre nel sequestro Moro del 1978 le due fazioni si erano divise sulla possibilità di supportare il governo nel far ritrovare il Presidente della DC. Sono gli anni spartiacque di tanti equilibri fra prima e seconda guerra di mafia e prima e seconda guerra di ‘ndrangheta poi, organizzazione che proprio in quegli anni si fa strada sotto le luci delle azioni roboanti di Cosa Nostra.
Le parole di Giuseppe Graviano a Reggio Calabria. Le ultime tre udienze del processo che si sta tenendo a Reggio Calabria che ha preso il nome dell’ordinanza che l’ha generato, ‘Ndrangheta stragista, hanno visto risaltare le dichiarazioni spontanee del boss Giuseppe Graviano, soprannominato dai suoi collaboratori “madre natura” e boss di riferimento del quartiere palermitano di Brancaccio (ma non solo) oltre che fedelissimo di Totò Riina. Graviano, già condannato all’ergastolo, è imputato insieme al boss della ‘ndrangheta Rocco Santo Filippone, legato alla potente cosca dei Piromalli di Gioia Tauro, di essere stato tra i mandanti degli agguati ai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, in uno dei quali furono uccisi due sottufficiali Antonino Fava e Vincenzo Garofalo mentre pattugliavano l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’impianto accusatorio della procura di Reggio Calabria nel processo vede come protagonista la ‘ndrangheta, al pari di Cosa Nostra, nell’attacco allo Stato tra il 1993 e il 1994 in quella che fu definita la stagione delle stragi continentali con gli attentati di Firenze, Milano e Roma.

Archivio Daniele Vianni (VerdeAzzurro notizie) Via Palestro Milano – Padiglione d’Arte Contemporanea
Graviano per molto tempo, e solo con qualche excursus dichiarativo sibillino in altri processi, non aveva mai chiesto di essere interrogato. Ma dal 23 gennaio 2020 ha cominciato a rispondere in video conferenza alle domande del procuratore Giuseppe Lombardo dopo aver ascoltato le intercettazioni che lo riguardano sulle conversazioni in libertà avute con un altro detenuto Umberto Adinolfi. Lo ha fatto come se fosse stato un dichiarante spontaneo cercando anche di gestire l’interrogatorio e rispondendo di fatto con lunghe dichiarazioni. Tutte e tre le udienze – la prima solo in modo generico – sono state condite da dichiarazioni su Silvio Berlusconi negando sin dall’inizio le accuse di stragi e omicidi a Graviano rivolte: sia nei procedimenti passati in giudicato, e nei quali è stato condannato, sia nel processo in questione. Sono certamente parole che sanno di messaggi, come è normale che sia da parte di chi non ha mai smesso di essere e sentirsi un boss, ma sono anche state affermazioni piene di dettagli riguardanti i rapporti di affari che Berlusconi avrebbe tenuto con il nonno di Graviano e che poi sarebbero passati in “eredità” allo stesso Graviano e al cugino. Il punto è che “madre natura” non ha fatto riferimento soltanto a fatti che sono usciti anche sui media e sulle carte di alcune sentenze che l’imputato ha dimostrato di saper analizzare e leggere (per suo torna conto certo ma non solo). Tra le affermazioni da lui pronunciate, infatti, oltre ai presunti 3 incontri che sarebbero stati consumati fra lui, Berlusconi e altre persone da lui non conosciute (udienza del 7 febbraio, riferimento a tre incontri quando Graviano era latitante), e oltre a frecciate lanciate ai vari “misteri d’Italia” dei quali certamente Graviano è a conoscenza anche per via indiretta, tra le cose da lui dette, dicevamo, a colpire sono stati quei riferimenti all’esistenza di carte/accordi privati quindi a elementi che eventualmente potrebbero provare concretamente l’esistenza di quei rapporti. Rapporti che risalgono – secondo Graviano – alla volontà del nonno materno del boss Filippo Quartararo allora facoltoso commerciante che sarebbe stato incaricato da Cosa Nostra di agganciare Berlusconi – con cui era in contatto – per investire al Nord. Cosa che sarebbe avvenuta per le pressioni di Giuseppe Greco padre del noto “Papa” Michele Greco che consigliò di investire nel settore immobiliare una cifra di circa 20 miliardi di lire. La carta privata secondo il racconto di Graviano sarebbe servita a occultare i legami di Cosa Nostra con gli investimenti immobiliari del gruppo di Berlusconi, almeno in un primo momento. Graviano insiste:
“Io sono stato arrestato per un progetto che è stato voluto da più persone. È dimostrato dal fatto che ogni giorno ricevevo visite, e non so se venivano registrato. C’erano carabinieri, poliziotti. E alla fine mi hanno detto: ‘Ora l’accuseremo per tutte le stragi d’Italia, da qui non uscirà più. E così è stato. E subito dopo ho ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare di Roma”. (Udienza del 14 febbraio 2020). Graviano cerca insomma di addebitare a un grande complotto contro di lui gli arresti che lo hanno visto protagonista. Un riferimento sibillino ma rilevante lo ha fatto durante la prima udienza del 23 gennaio nella quale al pm Lombardo Graviano aveva “consigliato” di andare a vedere il giorno del suo arresto, il 27 gennaio 1994 per capire cosa c’è dietro le stragi. Una prima lettura di superficie dopo che nelle udienze successive Graviano lo chiarisce è certamente questo “complotto” per incastrarlo. Ma un secondo livello di lettura porta invece all’ufficiale scesa in campo dell’imprenditore poi presidente del Consiglio, il 26 gennaio: il giorno prima. L’avvocato di Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha bollato come diffamatorie e prive di fondamento le parole di Graviano e, anzi, le lega a una reazione della mafia contro l’ex premier. Azioni che tuttavia Graviano stesso definisce come vero e proprio “tradimento” nei confronti della compagine mafiosa.

Via D’Amelio (Wikipedia)
Tornando a ‘San Valentino’. E’ proprio dalle ceneri di quelle prime indagini e dal rapporto riferito a inizio articolo (Rapporto Criminalpol n. 0500/C.A.S) che è necessario tornare per analizzare queste dichiarazioni. Nel processo che poi portò alla definitiva condanna di Marcello Dell’Utri, preceduta e seguita da diverse vicissitudini compresa la fuga dell’ex senatore di Forza Italia, poi rientrato in Italia, il pg aveva affermato che “per diciotto anni, dal 1974 al 1992, Marcello Dell’Utri è stato garante dell’accordo tra Berlusconi e Cosa nostra; in quel lasso di tempo”, aveva osservato il pg, “siamo in presenza di un reato permanente”. “Infatti, la Cassazione, con la sentenza del 2012 con cui aveva disposto un processo d’appello-bis per Dell’Utri, aveva precisato che l’accordo tra Berlusconi e Cosa nostra, con la mediazione di Dell’Utri c’è stato, si è formato nel 1974 ed è stato attuato volontariamente e consapevolmente”. La Cassazione nel 2014 confermando a 7 anni la condanna non mise in discussione queste assunzioni. E i rapporti fra Berlusconi, i mafiosi Gaetano Cinà (deceduto nel 2006), Stefano Bontade e Mimmo Teresi e Marcello Dell’Utri sono stati ricostruiti nella sentenza di primo grado del 2004 e recepiti nelle successive fino alla Cassazione nel 2014. Sentenza che si riferisce a un incontro avvenuto tra questi signori nel maggio del 1974. Nelle carte della sentenza contro Dell’Utri si parla del progetto di sequestro a Berlusconi voluto da Michele Greco il Papa – sequestro poi tramontato proprio perché si decise di trattare con l’imprenditore e affiancargli Mangano – secondo quanto riferì un collaboratore di giustizia, Antonino Giuffrè. Greco-figlio il cui padre secondo Graviano avrebbe consigliato l’investimento nelle costruzioni di Milano 2 o 3. Degli stessi investimenti senza un riferimento preciso quanto quello di Graviano ha parlato un altro collaboratore di Giustizia Francesco Di Carlo. Ed è sempre in queste carte che si parla della telefonata fra Dell’Utri e Mangano acquisita dalle carte sulle indagini della Criminalpol dell’81 che indagava fra imprenditoria del nord, cosa nostra e ‘ndrangheta. A carico di dell’Utri infatti erano stati emessi, riferisce la sentenza, “una comunicazione giudiziaria ed un decreto di perquisizione” secondo l’articolo 416bis. La sua posizione fu poi separata nel 1987 e con sentenza del 24 maggio 1990 di Milano si ritenne “insussistente la prova dell’inserimento dell’imputato Dell’Utri nel sodalizio mafioso operante a Milano”. Sono gli anni quelli indicati nella sentenza Dell’Utri ai quali fa riferimento il racconto di Graviano? La domanda è lecita.

ATTENTATO SAN GIOVANNI IN LATERANO (ROMA)
‘Ndrangheta e Cosa Nostra. Del tentativo di sequestro di Berlusconi, del quale la sentenza contro l’ex senatore di Forza Italia si parla e viene recepita nell’insieme come elemento significativo dei rapporti fra Berlusconi e Cosa Nostra mediati da Dell’Utri, esiste anche la dichiarazione di Angelo Siino, ex ‘ministro dei lavori pubblici’ di Totò Riina e collaboratore di giustizia considerato credibile da sempre, che durante una udienza del processo contro Andreotti nel 1997 fa riferimento alla ‘ndrangheta, ossia alle famiglie vertice della organizzazione calabrese, svelando così un diverso più recondito risvolto sui tentativi di rapimento dell’imprenditore e/o dei suoi figli. A rivelare per primi questa importante dichiarazione è il Corriere della Calabria nel 2013 (lo stesso anno della sentenza a Dell’Utri poi confermata dalla Cassazione) ma sono contenuti presenti nelle carte al processo Andreotti per mafia appunto, emersi soltanto alcuni anni dopo. Qui entra in scena un importante elemento cerniera tale Enzo Cafari (di cui ho scritto ne La Criminalità servente nel caso Moro , a proposito dell’omicidio del giornalista Pecorelli).

Giulio Andreotti Min. esteri e Silvio Berlusconi 1984 (Wikipedia)
Siino, riferisce la stessa sentenza di Palermo contro Andreotti e più in là negli anni recepita anche dalla sentenza contro dell’Utri, parla di un viaggio fatto a Milano con il massone calabrese Cafari – legato a tante storie delicate di ‘ndrangheta – e Bontade per cercare di convincere i calabresi – i Condello – a non rapire Berlusconi. Nelle confessioni di Siino c’è tutto il mondo descritto sopra: Sindona, la loggia Camea (“espressione nazionale rappresentata a Palermo dalla loggia Orion”) gli incontri con personaggi di spicco della ‘ndrangheta. Insomma la rete tessuta intorno a Dell’Utri e Berlusconi.
In quelle rivelazioni di Siino, infatti, si comprende come i rapporti fra Cosa nostra e ‘Ndrangheta fossero già cementati negli anni 70 e negli anni delle “stragi continentali” divengono dirimenti per una comune strategia. Il direttore allora del Corriere della Calabria, Pollicheni, che aveva condotto l’inchiesta e rivelato le parole di Siino, aveva affermato in una intervista su Il Sussidiario:
“Per la ‘Ndrangheta Berlusconi era solo un ricco imprenditore. Per Cosa nostra, che all’epoca era la leadership criminale, il Cavaliere era molto di più. Non dimentichiamo che era l’uomo della P2, tanto è vero che per salvarlo si mobilitò anche la Massoneria. Berlusconi stava iniziando a gestire le reti e i ripetitori per costruire il suo impero televisivo e si accingeva ad acquistare la Standa, da cui avrebbe tratto benefici anche Cosa nostra. Era inoltre un imprenditore vicino al Partito Socialista, cioè agli ambienti craxiani e quindi ai cementi della famiglia Gardini. Per Cosa nostra poteva rendere quindi molto di più farsi amico Berlusconi piuttosto che rapirlo.”
Le vicende della gestione delle reti e dei ripetitori per costruire l’impero televisivo sono tutte state recepite nella sentenza Dell”Utri.
E’ solo un’analisi questa dei fatti che si sono alternati in questi anni sotto una luce nuova e i loro collegamenti con le recenti vive vicende dei processi che sono in corso.
L’articolo ripreso da Antimafia 2000
NOTE: LE IMMAGINI UTILIZZATE PROVENGONO, A ECCEZIONE CHE LA’ DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, DA WIKIPEDIA. IN PARTICOLARE, PER LA FOTO DELL’ATTENTATO A SAN GIOVANNI IN LATERANO A ROMA WIKIPEDIA INDICA UN AUTORE ANONIMO: “INDECISO 42”. NEL CASO DI RIVENDICAZIONE AUTORIALE E RICHIESTA DI RIMOZIONE PREGO CONTATTARE L’INDIRIZZO simozecchi@gmail.com
QUESTO ARTICOLO PUBBLICATO SU BLOG PERSONALE DELL’AUTRICE E GIORNALISTA SIMONA ZECCHI RISPETTA TUTTI I CRISMI DEONTOLOGICI COSI’ COME INDICATI NEL TESTO UNICO DEL GIORNALISTA ED E’ INEDITO (ALLRIGHTS RESERVED)
L’omicidio Mattei e l’«Appunto 21»: due piste monche (estratto da “Massacro di un Poeta”)
E’ solo un estratto di un capitolo denso di fatti e analisi. In questo primo paragrafo ripercorro la genesi di “Petrolio” nelle intenzioni di Pier Paolo Pasolini, nei successivi spiego perché poi la chiave dell’Appunto 21 legata alla morte di Enrico Mattei è una chiave monca, che non apre la porta dove si cela il movente vero.
Le pagine mancanti
Negli ultimi cinque anni di indagine, ovvero dal 2010 al maggio 2015, si è fatto spesso riferimento a Petrolio, l’ultima opera, incompiuta, di Pier Paolo Pasolini, la cui stesura ebbe inizio nella primavera del 1972. Una «presenza» che ha viaggiato in parallelo, senza mai incontrarsi concretamente, con l’inchiesta sulla morte del poeta. Un corpus «ingombrante» verso cui personaggi della politica, dell’industria, testimoni e intellettuali hanno via via mostrato il loro interesse appropriandosi di questo o quell’elemento. Il vocio che si è raccolto intorno ad essa ha smorzato però alcune verità. La Procura di Roma, infatti, non si è mai addentrata nelle pagine di quel testo alla ricerca di elementi che permettessero agli investigatori di andare oltre il movente sessuale ampiamente smontato nel presente libro. Un magistrato di un’altra procura lo ha fatto, vedremo come.
Petrolio o Vas (titolo poi scartato dall’autore) è un vero e proprio documento, come lo è La Divina Mimesis e, sotto altra forma, il film Salò. Tutte e tre le opere sono percorse dallo schema dei gironi infernali danteschi, trasposti in un contesto contemporaneo, sul quale il poeta affonda le sue critiche taglienti e percorre la sua personale indagine. Lo stile usato in Petrolio è quello «che si adopera per la saggistica, per certi articoli giornalistici, per le recensioni, per le lettere private o anche per la poesia: rari sono i passi che si possono chiamare [decisamente] narrativi», come scrive Pasolini stesso nella lettera ad Alberto Moravia mai spedita e apposta in calce all’opera. Una sorta di superamento della forma romanzo, la quale, secondo il poeta, non è più sufficiente a far comprendere la verità dei fatti al lettore:
“Se io dessi corpo a ciò che qui è solo potenziale, e cioè inventassi la scrittura necessaria a fare di questa storia un oggetto, una macchina narrativa che funziona da sola nell’immaginazione del lettore, dovrei per forza accettare quella convenzionalità che è in fondo giuoco. Non ho voglia più di giocare”.
All’amico e scrittore Paolo Volponi, Pasolini riferisce:
“Deve essere un lungo romanzo, di almeno duemila pagine. S’intitolerà Petrolio. Ci sono tutti i problemi di questi venti anni della nostra vita italiana politica, amministrativa, della crisi della nostra repubblica: con il petrolio sullo sfondo come grande protagonista della divisione internazionale del lavoro, del mondo del capitale che è quello che determina poi questa crisi, le nostre sofferenze, le nostre immaturità, le nostre debolezze, e insieme le condizioni di sudditanza della nostra borghesia, del nostro presuntuoso neocapitalismo”.
Lo scrittore corsaro, dunque, non ha più voglia di «giocare». È un cambio di passo il suo: linguistico, stilistico e di forma. Vuole confrontarsi con la realtà utilizzando il giornalismo investigativo (mediante l’uso incrociato delle fonti e il loro collegamento) pur non rinunciando alla sua anima da letterato.
Durante la prima presentazione del libro nel 1992, il filologo Aurelio Roncaglia motiva così la lunga attesa per la pubblicazione:
“Abbiamo atteso tanto prima di tutto per i temi scottanti, sia dal punto di vista politico che erotico, che Pasolini tratta; in secondo luogo perché un’opera di una tale incompiutezza poteva anche nuocere all’autore. Ma non potevamo censurarlo. Anche Piero Gelli, direttore editoriale di Einaudi, ha ammesso di aver avuto qualche perplessità trattandosi di un’opera scomoda.”
Cinquecentoventidue pagine o veline (il tipo di carta utilizzata da Pasolini), per lo più dattiloscritte, invece delle duemila programmate che avrebbero dovuto raccogliere l’intera visione pasoliniana del potere.
Il 26 dicembre del 1974, tuttavia, come riferisce anche Roncaglia nella nota filologica all’opera, Pasolini si esprime in modo piuttosto preciso in merito al numero delle pagine:
“Nulla è quanto ho fatto da quando sono nato, in confronto all’opera gigantesca che sto portando avanti: un grosso Romanzo di 2000 pagine. Sono arrivato a pagina 600, e non le dico di più per non compromettermi”.
Il 10 gennaio 1975, sulla Stampa, il poeta ripete la stessa cifra al giornalista Lorenzo Mondo: «Seicento pagine abbozzate sulle duemila definitive». È la conferma della mancanza o addirittura della scomparsa di circa settantotto pagine (600-522) del dattiloscritto, quantomeno stando agli elementi certi a disposizione. Il numero indicato dallo scrittore è così preciso che la laconica spiegazione, nella stessa nota filologica di Roncaglia, secondo cui la cifra annunciata da Pasolini era un arrotondamento per eccesso, resta insufficiente.
Da Pasolini Massacro di un Poeta (Ponte alle Grazie 2015) allrights reserved

Il “caso Moro”, Sciascia, Mattarella e la Sicilia
di Simona Zecchi
Scriveva Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera nel 1982: «Si è parlato – e molti che non ne hanno parlato ci hanno creduto – della ‘geometrica’ perfezione di certe operazioni delle Brigate Rosse: e si è poi visto di che pasta sono fatti i brigatisti e come la loro efficienza venisse dall’altrui inefficienza. Arriveremo alla stessa constatazione – almeno lo spero – anche con la mafia.»
Già altrove lo scrittore siciliano era ricorso a rappresentare le due ‘forze’ – terrorismo e mafia – come motrici entrambe degli omicidi Mattarella (Piersanti, ammazzato il 6 gennaio 1980) e Reina (Michele, ammazzato il 9 marzo 1979). Scriveva in particolare il 7 gennaio del 1980 sempre sul Corriere:«Io sono stato tra i pochissimi a credere che Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, fosse stato assassinato da terroristi. Terroristi magari un pò sui generis, come qui ogni cosa; ma terroristi. […] Oggi di fronte all’assassinio del presidente della Regione Mattarella, quella mia ipotesi, che quasi mi ero convinto ad abbandonare, mi pare che torni a essere valida.» Giovanni Falcone, infatti, titolare della prima istruttoria sull’omicidio di Piersanti Mattarella aveva sin da subito indirizzato le indagini verso una pista nera per ciò che riguardava gli assassini materiali di cui chiese l’arresto nel 1986. Quella istruttoria culminò in una requisitoria depositata nel 1991 che poi non ebbe conferme giudiziarie ma che proprio recentemente ha di nuovo fatto capolino. Mattarella ha rappresentato in terra siciliana, per ciò che riguarda il compromesso storico fra PCI e DC, quello che Aldo Moro (con un percorso iniziato nel 1969 attraverso una sua “strategia dell’attenzione” verso il partito comunista italiano) è stato a livello nazionale, con tutte le specificità e le differenze che certo li caratterizzavano e che caratterizzavano le “due terre”: la Sicilia spesso per anni un mondo a parte, e il resto d’Italia. Una differenza che anche si inserisce nella questione del compromesso in sé a livello nazionale. Chi si è opposto a logiche criminali come Mattarella e Reina si era anche opposto a un sistema di potere più complesso e ampio. Nel caso di Mattarella parliamo -secondo quanto emerse allora e permane come sospetto per il momento oggi – di terrorismo nero oltre all’intervento di Cosa Nostra. Per quanto riguarda il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro – strage degli agenti annessa-, l’evento spartiacque per gli equilibri nazionali indicativi per Moro di un cambiamento nel Paese al quale dare inizio, si è trattato di terrorismo rosso. Il colore politico, è ormai giunto il momento di dichiararlo con coraggio, cambia soltanto in funzione di dinamiche ma non di resa, di risultati.
Cambiare approccio per ricostruire i cinquantacinque giorni del Caso Moro nella inchiesta da me condotta e culminata nel libro, “La Criminalità servente nel Caso Moro” ha significato certo attraversare quaranta anni di storia politico-criminale e di contesti politici nazionali e internazionali, ma non da ultimo ha inoltre significato raccogliere i fatti che conducevano verso quel filone, esaminarli in controluce ed esporli tutti in fila come se posti su un tavolo immaginario (anche se in realtà fisicamente è avvenuto proprio così), certo verificandoli. Lavorare su temi così complessi non può prescindere dall’analisi dei fatti e dei contesti insieme. Concentrarsi soltanto su uno dei due fattori rende il quadro intero sbilanciato nelle sue tinte. Così, la tavolozza che mano a mano ne è emersa non lasciava scampo: i vertici della criminalità organizzata e delle consorterie che la costituivano in quegli anni (attenzione non pedine o anche soltanto boss qualunque seppure di rilievo) hanno influito e operato nel Caso Moro, moltissimo. Non soltanto per ciò che riguarda le presenze di uomini della ‘ndrangheta accertate o ancora da accertare sul luogo della strage, Via Fani, dove alle 9.02 del mattino la raffica di fuoco incrociato è partita, ma anche per quanto riguarda la gestione del sequestro fino alla consegna di Moro morto in Via Caetani, riverso nell’abitacolo di una Renault 4 rossa, e per le connivenze tra frange della lotta armata allineate alle BR e la criminalità organizzata e comune. A parte, poi, va considerato l’aspetto forse più noto al grande pubblico: il ruolo di alcune organizzazioni criminali nel tentativo di liberazione dell’onorevole Moro. Aspetto questo che ricostruito da me interamente dall’inizio, compiendo tabula rasa su quanto scritto e raccolto sino a quale momento da altri, ha anche fatto emergere dettagli e aneddoti rilevanti e nuovi per la comprensione dell’Affaire tutto. L’insieme di questa distesa di elementi conducevano tutti in Calabria: la ‘ndrangheta, cresciuta nel corso degli anni all’ombra dei riflettori di una Cosa Nostra più ‘spettacolare’, infatti, rappresenta secondo quanto da me ricostruito la costante del Caso Moro e insieme la costante di altri eventi tragici che, come le ultime inchieste della Procura di Reggio Calabria certificano, ha attraversato questo Paese. Una costante operante quasi sempre con Cosa Nostra ma non necessariamente.
Durante il corso delle indagini che la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul caso stava svolgendo, ho seguito dunque un mio percorso investigativo parallelo supportato ovviamente dalla ricerca incessante e dallo studio degli atti passati e nuovi che come già svolto per un’altra inchiesta, quella sulla morte di Pier Paolo Pasolini, mi ha poi portato a sviscerare elementi inediti e anche alla ricostruzione di un contesto mai considerato prima in modo unitario. Fino a giungere agli anni della trattativa Stato-mafia così come la conosciamo, quella il cui processo di Palermo è da poco culminato a un primo grado di condanne e ad alcune assoluzioni (parziali o totali).
Il cuore di questo libro-inchiesta è costituito da due punti principali: da un lato la spiegazione del “mistero” del falso comunicato del lago della Duchessa, legato alla scoperta del covo di Via Gradoli il 18 aprile del 1978 nel bel mezzo del sequestro, e l’emersione di una nuova prigione in cui Aldo Moro è stato di passaggio durante la sua prigionia: un covo non lontano dal lago stesso nella Sabina fra il Lazio e l’Umbria, luogo legato a sua volta sia a elementi della lotta armata sia alla criminalità; dall’altro, lo sviluppo delle inchieste del generale Dalla Chiesa e il giudice Vittorio Occorsio sulle morti dei quali pesa l’ombra sia della mafia sia del terrorismo: entrambi, infatti, stavano indagando su una struttura riservata composta da parti della massoneria, della criminalità organizzata, consorterie politiche e della magistratura, e di elementi del terrorismo di destra e di sinistra. Nel libro, tra le altre cose inedite, viene per la prima volta pubblicato l’estratto di un verbale sconosciuto alle cronache e alle ricostruzioni sin qui svolte, un verbale che porta proprio la firma del Generale. Intorno a questi due punti cardinali della inchiesta vengono da me sviluppati ulteriori fatti e risvolti a essi collegati. La “geometrica potenza” invocata da Sciascia, espressione usata in un articolo sequestrato a Franco Piperno leader di Potere Operaio, e operativo presso l’Università della Calabria, si dispiega tutta qui.
Attraverso un metodo giornalistico che definisco “della piramide rovesciata” arrivo dunque al cuore del Caso Moro cercando di consegnare un pezzo di verità mancante di questo segreto usurato della Repubblica. Con le “prove” che un giornalista umilmente può portare.
Testo pubblicato sul Blog di La Repubblica “Mafie” di Attilio Bolzoni il 22 giugno 2018

